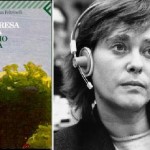 Oggi Mariateresa Di Lascia avrebbe avuto cinquantacinque anni, è morta che ne aveva quaranta. Quattordici anni fa, nel gennaio del 1995 quattro mesi dopo la sua morte, Feltrinelli pubblicava il suo romanzo Passaggio in Ombra che avrebbe vinto nel settembre dello stesso anno il Premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Una grande saga familiare costruita con colori, odori e storie della terra di Puglia. Una terra troppo spesso bistratta, offesa e umiliata, ma sempre generosa.
Oggi Mariateresa Di Lascia avrebbe avuto cinquantacinque anni, è morta che ne aveva quaranta. Quattordici anni fa, nel gennaio del 1995 quattro mesi dopo la sua morte, Feltrinelli pubblicava il suo romanzo Passaggio in Ombra che avrebbe vinto nel settembre dello stesso anno il Premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Una grande saga familiare costruita con colori, odori e storie della terra di Puglia. Una terra troppo spesso bistratta, offesa e umiliata, ma sempre generosa.
Nata a Rocchetta Sant’Antonio dopo un breve passaggio a Napoli per studiare medicina, fin da giovanissima s’impegna nel Partito Radicale. Un impegno che le consente di diventarne il vicesegretario, nel 1982, e di essere, seppur per un tempo brevissimo, deputato nella IX legislatura.
Il suo profilo politico è un profilo tipicamente radicale, nel senso più pieno del termine. Battaglie per i diritti umani e per i diritti civili, emancipazione femminile e sempre in prima fila nelle battaglie contro il nucleare. Nel 1993 fonda con Sergio D’Elia, che diventerà suo marito l’anno seguente pochi mesi prima di morire, Nessuno tocchi Caino, una lega transnazionale di cittadini e parlamentari, senza fini di lucro, per l’abolizione della pena di morte nel mondo.
Accanto all’impegno politico nella vita di Mariateresa c’è stata la letteratura. Una passione che si è concretizzata in quattro racconti e tre romanzi di cui uno, l’ultimo, non terminato.
Ma andiamo con ordine e torniamo alla politica e all’impegno per la democrazia.
«I radicali, cifre alla mano, dimostrano l’unica cosa che il clamore filonuclearista non ha mai lasciato venire fuori: il nucleare è economicamente sconveniente, costa moltissimo e rende pochissimo. Fatti i conti in tasca all’Enel, l’azienda elettrica nazionale; sciorinata la lista dei miliardi sprecati -in Italia e fuori avvalendosi del trattato sull’Euratom- per una ricerca unidirezionale e senza futuro, la verità che emerge è che il tutto nucleare può coprire, entro il 2000, solo il 10% del fabbisogno energetico mondiale. Il grande dogma scientifico per il quale bastava un’unica fonte di energia per coprire le esigenze del pianeta è stato sconfessato da anni di politica energetica solo nuclearista mentre appare sempre più evidente che il problema è quello della conservazione e dell’uso appropriato e molteplice delle diverse fonti di energia. Le regole dell’ecologia come nuova e necessaria economia s’impongono a tutti[…] È la fine di un mito e l’inizio di una nuova riflessione. I radicali ne sono gli artefici.»
Questo scriveva Mariateresa Di Lascia nell’aprile del 1989, quando la Storia, quella con la S maiuscola appunto, stava per passare sulle nostre teste e il futuro sembrava essere a portata di mano. In questo intervento, preparato per il 35 congresso del partito radicale che si svolse a Budapest, i temi che la Di Lascia tratta sono temi della nostra contemporaneità: un modello di sviluppo che non pregiudichi il futuro del nostro pianeta. Uno sviluppo basato sul risparmio energetico e che prevede l’uso di diverse fonti di energia e mai la produzione di energia nucleare. Battaglia questa contro la creazione di nuove centrali nucleari, che deve essere transnazionale, come transnazionale era il partito che aveva scelto e nel quale militava. Una battaglia che anticipava molte delle questioni di cui ancora si discute, e che proprio oggi sono al centro del dibattito politico non solo italiano ma che in Italia hanno avuto un nuovo impulso nel mare magnum di proposte sconclusionate e senza visione del governo in carica.
Accanto a questo che potremmo definire il tema dei temi, lo sviluppo e il futuro del pianeta, Mariateresa Di Lascia, così come il partito radicale, si è sempre occupata del tema dei diritti. Diritti umani e diritti civili. Ecco cosa scrive nel luglio del 1993 in occasione della consegna a Ibrahima Fall, segretario della Conferenza sui diritti umani, di oltre 60.000 firme raccolte in sessantasei Paesi per la Campagna parlamentare mondiale per l’abolizione della pena di morte entro il 2000. L’incontro avvenne a Vienna.
«Il meeting si svolge in una stanzetta di un metro per due, dove si ammucchiano una decina di giornalisti, mescolati alla delegazione del Partito radicale e della Lega per l’abolizione della pena di morte entro il 2000. Essa è così composta: Nikolaj Arzhannikov, vice presidente della Commissione dei diritti umani del Parlamento russo; Igor Bezrukov, vice presidente della Commissione legislativa del Parlamento russo; Emma Bonino, Segretario del Partito radicale transnazionale, membro della presidenza della Camera dei deputati; Adelaide Aglietta, relatrice sulla pena di morte al Parlamento europeo e presidente del Gruppo verde; Hans Janitschek, già presidente dell’Internazionale socialista; Zvonimir Separovic, presidente della Società di Vittimologia della Croazia; Enrico Modigliani e Alfonso Pecoraro Scanio, deputati italiani; Antonio Stango, del Consiglio generale del Pr e segretario del Comitato italiano Helsinki, Sergio D’Elia, Mariateresa Di Lascia, Olivia Ratti, Lucio Berté e Irina Podlesova, della Lega internazionale per l’abolizione della pena di morte entro il 2000. Prende la parola per prima Emma Bonino, che parla inglese e francese con la stessa velocità con cui eloquia in italiano; presenta gli altri membri della delegazione e le ragioni della nostra presenza alla Conferenza di Vienna: oltre 60.000 firme da 66 paesi del mondo su due appelli rivolti alle Nazioni Unite. I giornalisti scrivono rapidi, fanno molte domande: chissà se è come in Italia, dove scrivono anche, ma raramente pubblicano una notizia di politica internazionale… Il giorno dopo, invece, il Der Standard -il maggiore giornale austriaco- scrive di noi in terza pagina: Il partito transnazionale radicale conta mondialmente più di 50.000 membri. L’impegno principale è l’abolizione della pena di morte e l’istituzione di un Tribunale internazionale contro i crimini di guerra.»
Una voglia di essere presente in prima persona nelle battaglie per il cambiamento, per i diritti e per la democrazia. Un impegno costante interrotto da una terribile malattia quando era nel pieno della maturità e delle forze.
C’era molto futuro nelle battaglie radicali di quegli anni. E c’era, ancora una volta in anticipo sui tempi, la discussione sul rapporto tra politica e partiti politici. Su questo tema ecco cosa scriveva Mariateresa in preparazione del 30 congresso del partito radicale, nell’aprile del 1984.
«La grande intuizione radicale è stata quella di capire che la messa in crisi dei meccanismi partitocratici passa attraverso la crescita della maggioranza silenziosa e della negazione del consenso alla politica in corso. L’implosione del silenzio fa impazzire i politici. Rafforzare questa intuizione significa far crescere lo sciopero del voto da un lato, offrire un’alternativa di gestione, dall’altro. Per questo credo che lo slogan fuori i partiti dai comuni sia forte e può dare grossi risultati. Sarebbe imbecille da parte nostra ritenere che sia preferibile mandare qualcuno di noi a fare il consigliere, ostaggio dei partiti, piuttosto che promuovere quanto di diverso e di alternativo c’è nella nostra società.»
Erano tempi in cui la nostra società esprimeva idee e progetti e accompagnava la politica nelle decisioni più importanti. Lo facevano le persone singole, quelle che s’impegnavano nei partiti, i giornali e il mondo dei media in generale. Spesso ne indirizzavano gli orientamenti in un continuo scambio, a volte anche conflittuale, ma sempre proficuo. Non eravamo, non lo era l’Italia, in una condizione di degrado antropologico, così come, in questi giorni, ha magistralmente definito la situazione in cui versa il nostro paese, Luciano Canfora.
Nella vita di Mariateresa oltre all’impegno politico e tanto altro ancora, c’è stata la letteratura. Un confronto continuo con il valore e il senso delle parole. Un tempo troppo breve e canaglia le ha impedito di approfondire questo rapporto ma non le ha impedito di attraversarci e lasciare traccia di se nelle nostre vite.

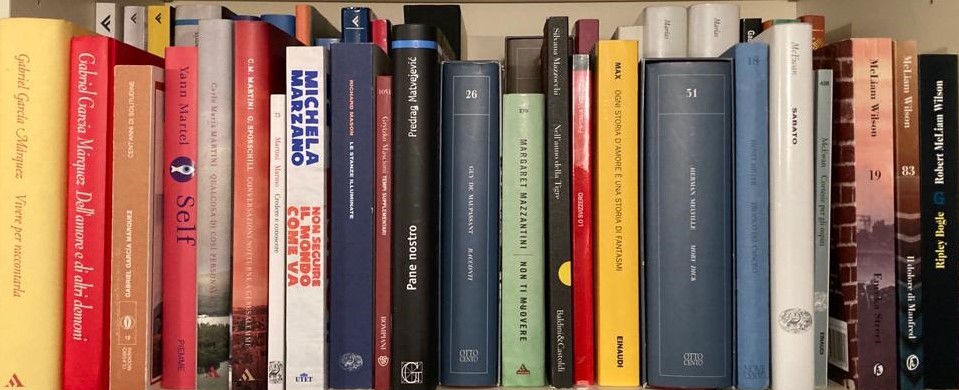
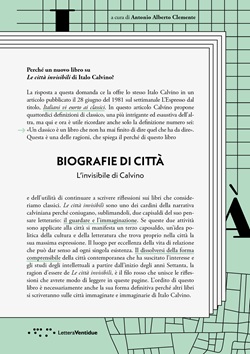
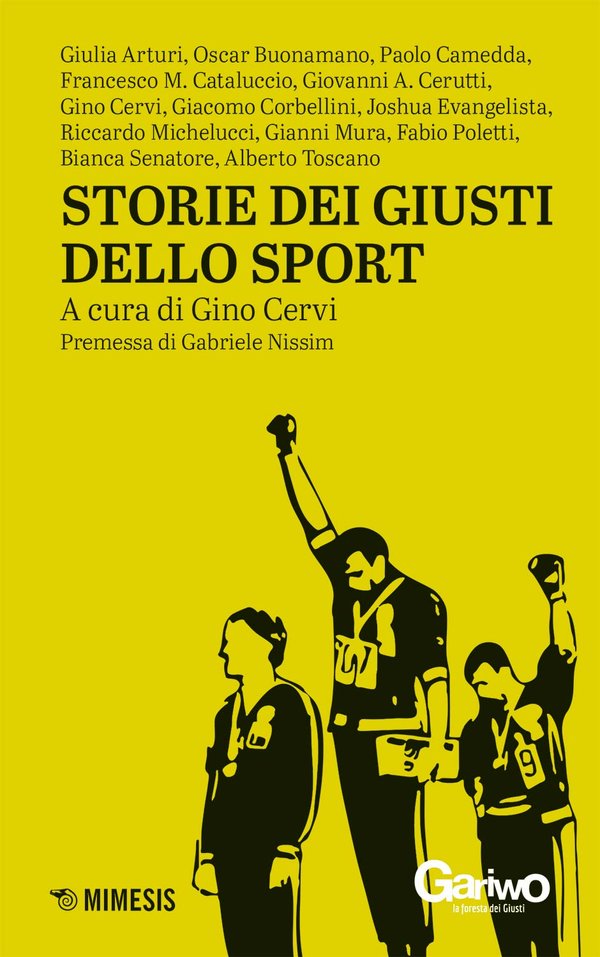
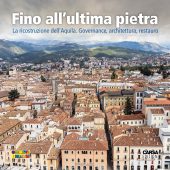
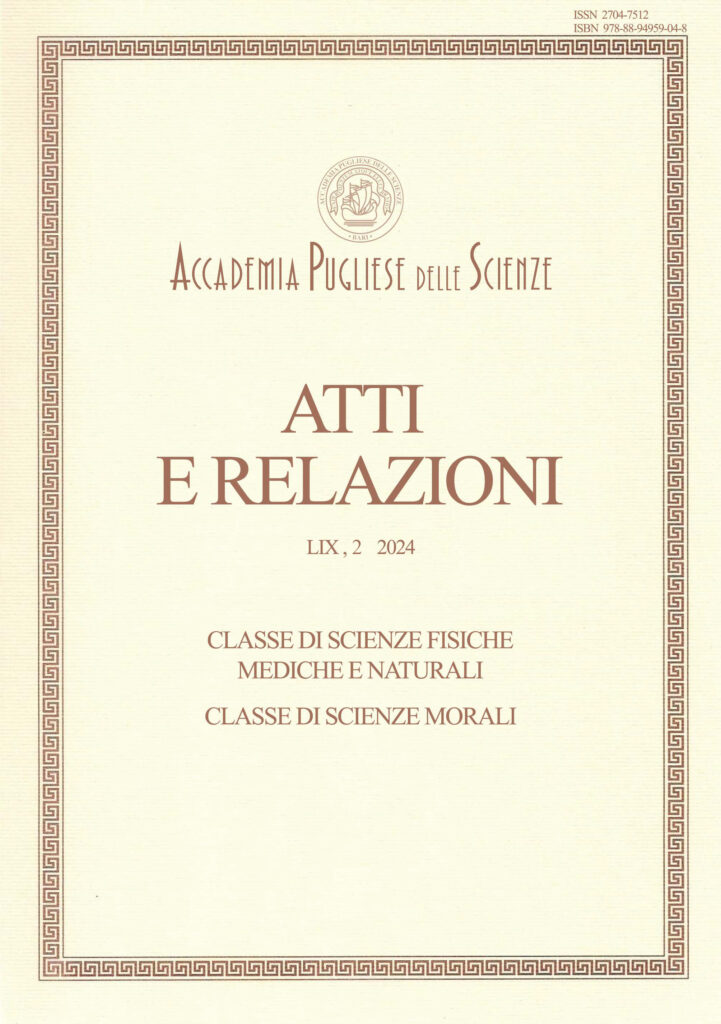

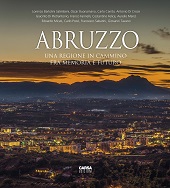
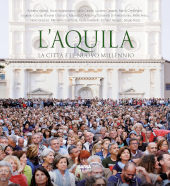
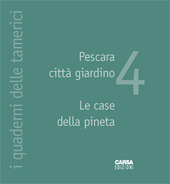



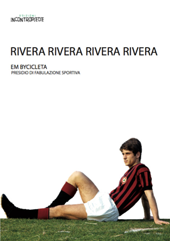
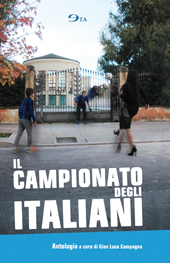
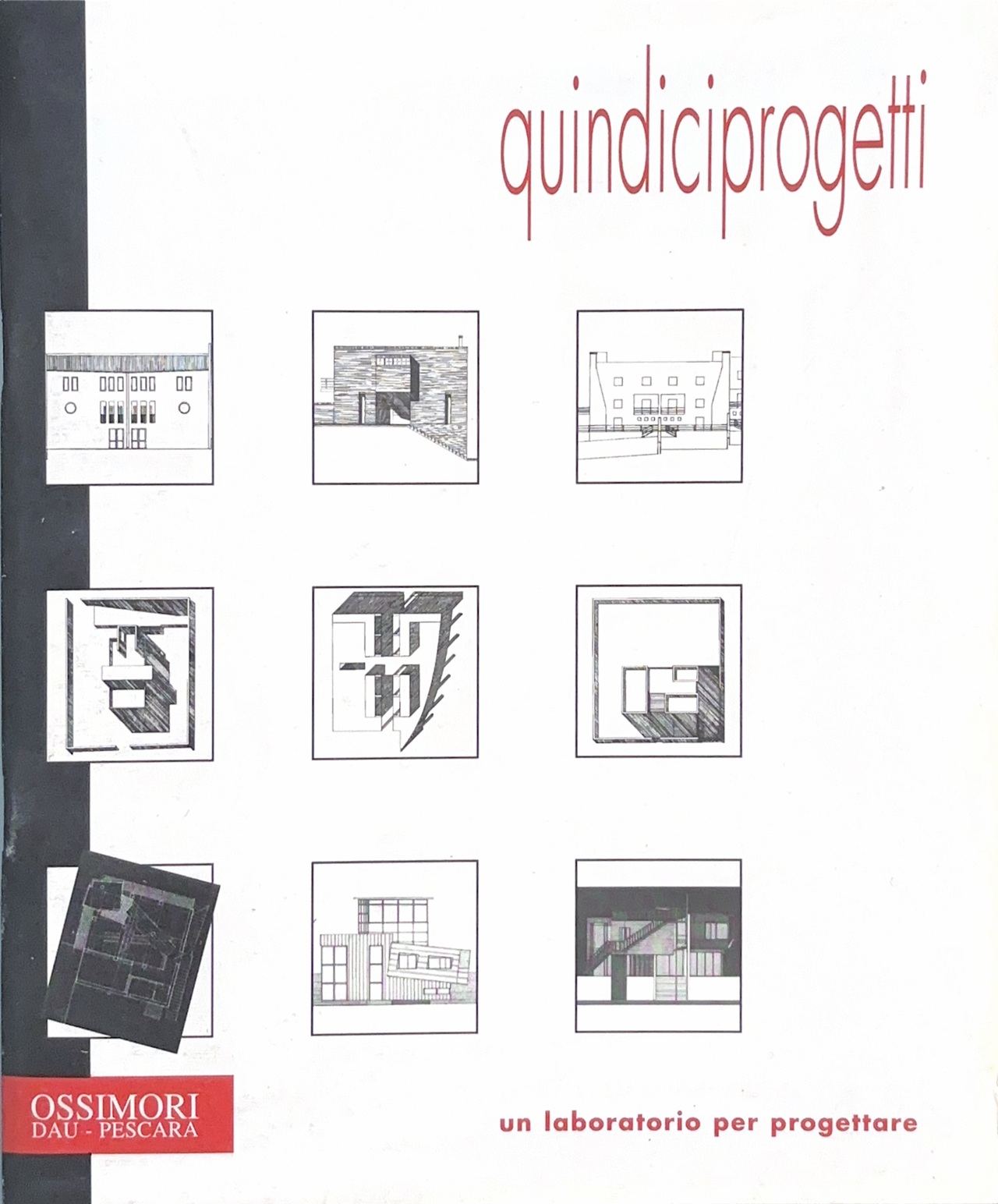





Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.