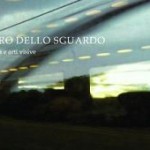 L’utopia di Roland Barthes di ripulire la scrittura da tutte le incrostazioni che l’abitano, riemerge dall’oblio di un sempre più afasico dibattito culturale per assurgere a nuova centralità, quasi come una necessità, nel Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo diretto da Enzo De Leonibus, artista e vero anfitrione. Barthes userà anche il termine “lingua bianca” per meglio descrivere ciò che intendeva per Grado zero della scrittura.
L’utopia di Roland Barthes di ripulire la scrittura da tutte le incrostazioni che l’abitano, riemerge dall’oblio di un sempre più afasico dibattito culturale per assurgere a nuova centralità, quasi come una necessità, nel Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo diretto da Enzo De Leonibus, artista e vero anfitrione. Barthes userà anche il termine “lingua bianca” per meglio descrivere ciò che intendeva per Grado zero della scrittura.
«Cerca cioè di mostrare come questa terza dimensione formale leghi lo scrittore alla sua società e di far risaltare come non ci possa essere letteratura senza morale del linguaggio».
Con una traslitterazione del concetto barthesiano i curatori della mostra Il grado zero dello sguardo, Maurizio Coccia, Giuseppe Di Liberti, Domenico Spinosa e lo stesso De Leonibus, squarciano un velo e, in totale controtendenza, indicano una strada possibile da percorrere sul sentiero sempre più stretto e impopolare della conoscenza. Realizzano un progetto che accosta fisicamente il lavoro di un’artista a un film e lasciano che le immagini, fisse o in movimento, interagiscano tra loro per creare un nuovo senso e, per certi versi, una nuova opera. Il lavoro finale è in questo senso un work in progress, un “non finito” o un “primo naufragio” come scrivono i curatori, in cui il giudizio e la consapevolezza dello spettatore giocano un ruolo decisivo per la comprensione delle nuove opere così concepite. Ci si può soffermare sulla singola installazione, sul singolo quadro o guardare una sequenza del film. Oppure semplicemente leggere il pensiero che li tiene assieme. Cogliere cioè frammenti del progetto in fieri e autocostruirsi un percorso conoscitivo in cui le relazioni e le corrispondenze non possono che confrontarsi e appartenere «alla soggettività più profonda di ognuno».
Interagiscono anche alcune delle opere che abitano stabilmente il Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo. È il caso del lavoro che apre il percorso espositivo, “Gran Sasso” di Emanuela Barbi. Una grande parete realizzata nel 2002, anno in cui si discuteva sull’opportunità di realizzare un terzo traforo nel cuore della vetta più alta degli Appennini. Un’opera che appartiene alla collezione del Museo e che abbinata al film di Kum Ki Duk, “Primavera – estate – autunno – inverno… e ancora primavera”, costituisce il primo frammento del un nuovo progetto. Un «montaggio critico», così come definito dagli stessi curatori, una giustapposizione d’immagini finalizzata alla costruzione di un progetto aperto a sollecitazioni anche esterne ma che realizza e propone già nella sua prima «stazione» nuove domande e insieme nuovi significati. Sul terreno della linguistica, passando da Barthes a Saussure, questa giustapposizione evidenzia e rende palese, indugiando sulle parole si potrebbe dire “in maniera plastica”, la differenza tra significante e significato. E perciò è di nuovo la soggettività di ognuno che recepisce, valuta e organizza.
Nella spazialità controllata dell’ex manifattura tabacchi dove il colore che prevale e accompagna è il bianco, le opere di Romano Bertuzzi, Bruna Esposito, Massimo Vitangeli, Yonel Idalgo Perez, Damiano Colacito, Matteo Fato, Fabrizio Segarizzi, Mariuccia Pisani, Giuseppe Stampone, Barbara Esposito e Franco Fiorillo oltre alla già citata Emanuela Barbi si relazionano rispettivamente ai film di Ermanno Olmi, Takeshi Kitano, Gonzalez Inarritu, Francis Ford Coppola, Ari Folman, David Linch, Pietro Marcello, Paolo Sorrentino, Werner Herzog, Lars von Trier e Kim Ki Duk. Un percorso circolare che cinge la corte interna, spazio essenziale e vitale, trait d’union tra un dentro e un fuori ma anche diaframma tra spazio interno e spazio esterno. Ancora una volta sono gli occhi di chi guarda a definire e determinare lo spazio e la collocazione delle opere in esso.
C’è un unico lavoro che non dialoga direttamente con nessun altra opera, ed è il film di Douglas Gordon e Philippe Parreno, “Zidane un ritratto del XXI° secolo”. In realtà quest’opera è già un dialogo artistico tra i due autori, il primo normalmente concentrato sui dualismi universali, vita e morte, bene e male, il secondo sulla «rielaborazione del concetto di narrazione, la riflessione sulla natura dell’immagine, sui sistemi di significazione e rappresentazione permessi dalle nuove tecnologie». Il film segue per un’intera partita, è il 23 aprile 2005 e si gioca Real Madrid-Villareal al Santiago Bernabeu, il campione franco-algerino. Non ci sono commenti e tutte le inquadrature sono concentrate esclusivamente sulle movenze e sull’espressioni del volto di Zinédine Zidane. Il risultato è l’inedito ritratto di un campione disegnato mentre svolge il suo lavoro, che posizionato alla fine del percorso espositivo ne segnala un suo nuovo possibile inizio. Un «nuovo giro di giostra» che può ripartire proprio dalla geniale intuizione di Gordon e Parreno per includere nella relazione a due già stabilita, cinema e arti visive, un terzo soggetto: la letteratura. In primo luogo della poesia, ma anche prosa e teatro, salvaguardando quell’atmosfera rarefatta e complice che questa mostra ha generato sotto forma di prosa d’arte.
In questa «terra di nessuno necessaria per modulare e realizzare progetti ed ossessioni» che è il Museo Laboratorio, è in atto dunque una reductio ad minimun da accogliere come salvifica in un mondo sempre più caotico, popolato da pseudoartisti, scrittori che si autodefinisco tali, nani e ballerine che impazzano da un tempo ormai infinito e che occupano sistematicamente quasi tutti gli spazi a disposizione. Una performance, un evento, raro e perciò necessario che induce a fermarsi per riflettere. A coltivare le pause. Le sospensioni.
Scrive Wim Wenders nell’introduzione a “Una volta”, un suo libro di fotografie: «Spero che questo libro di fotografie diventi un libro di storie. Non lo è ancora, ma lo può diventare attraverso chiunque abbia voglia di ascoltare il suo vedere». “Il grado zero dello sguardo. Primo naufragio: cinema e arti visive” è il luogo ideale per fermarsi, indugiare, e, ascoltando il proprio vedere, provare a costruire delle storie.

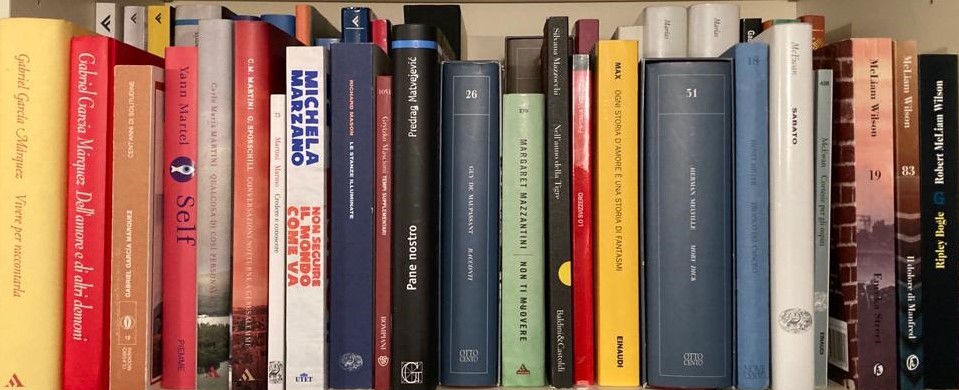
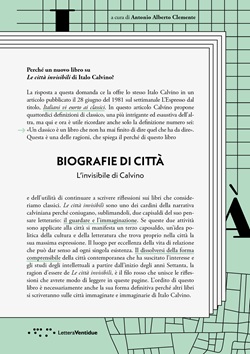
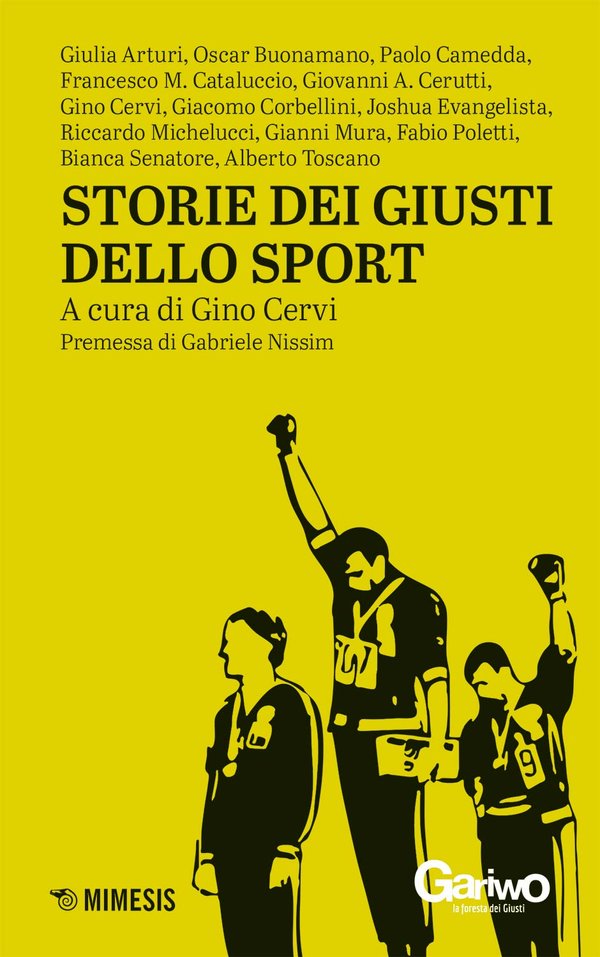
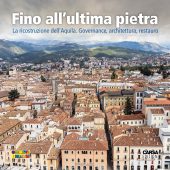
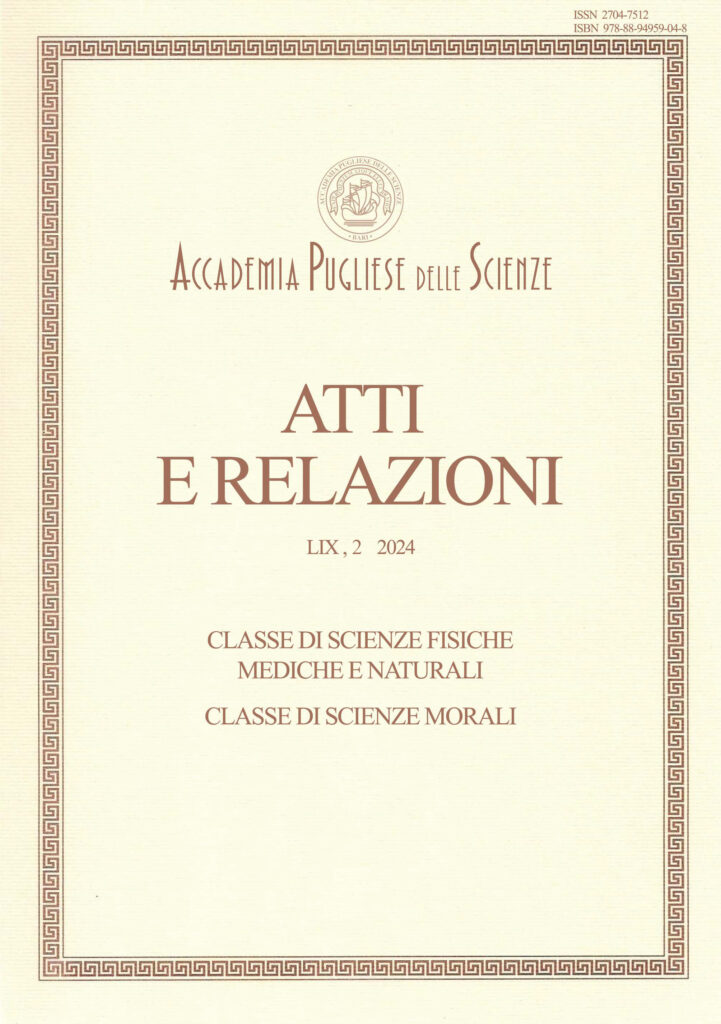

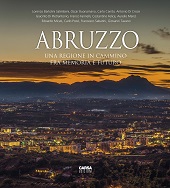
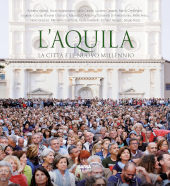
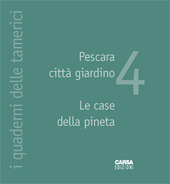



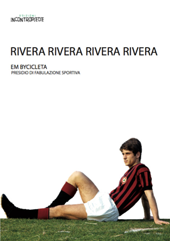
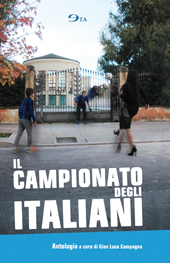
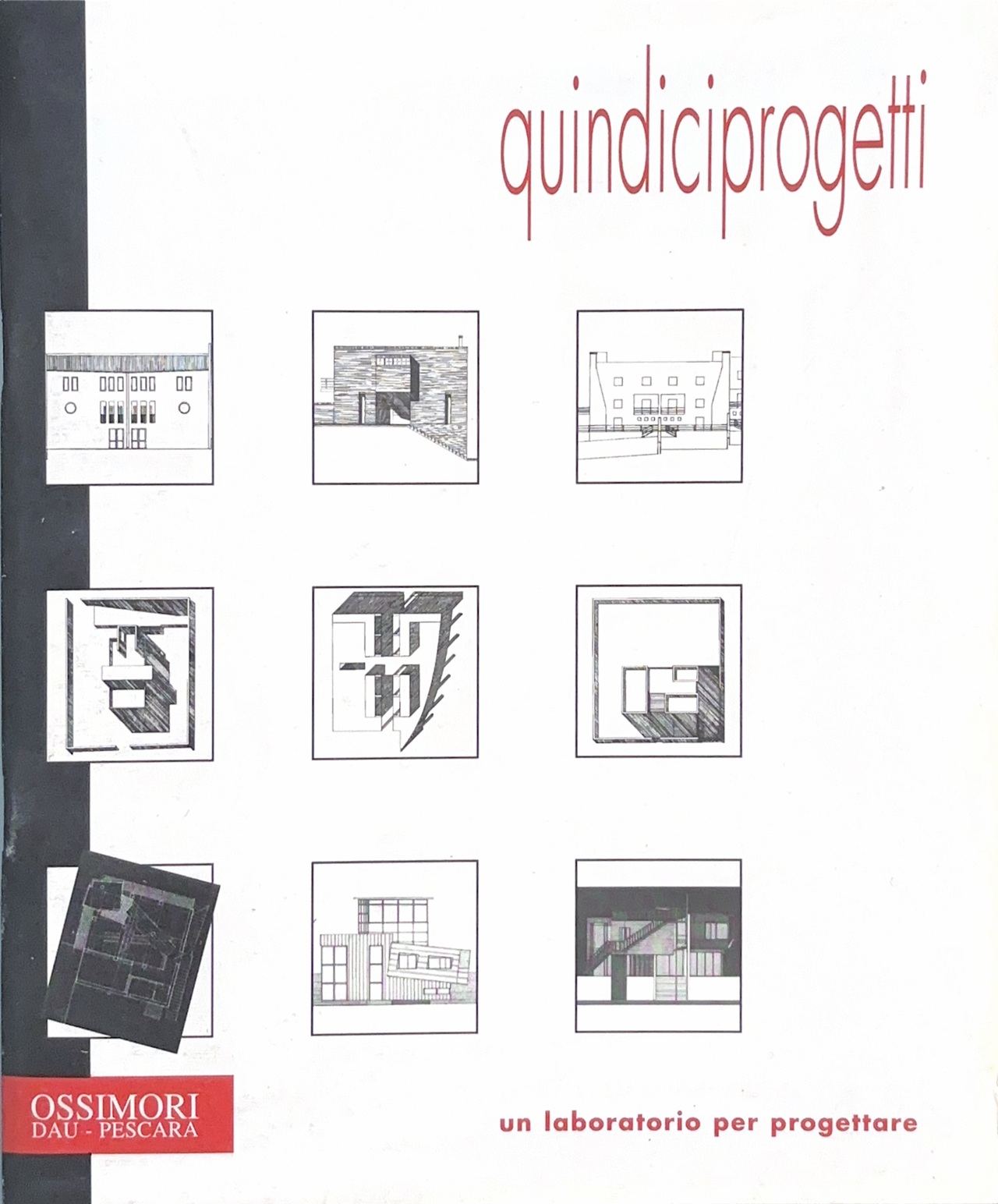






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.