L’influenza di Italo Calvino sulla cultura architettonica italiana viene esaminata a partire dagli anni Sessanta allorquando Calvino, totalmente immerso e protagonista della cultura a lui contemporanea, s’interrogava sul futuro della città e del progetto urbano. Un sentimento e una tensione diffusi in tutta Europa che aveva negli intellettuali italiani, teorici e progettisti, punti di riferimento imprescindibili. Contestualmente questa relazione ripercorre la riflessione sul progetto della Città ideale che dalla Torre di Babele, presente nella Genesi, attraversa il Rinascimento italiano per interessare teorici e artisti anche nella contemporaneità. È dunque la ricerca della felicità che tiene insieme Calvino, architetti e urbanisti, intellettuali e artisti, in una riflessione costante e continua su la «cosa umana per eccellenza», insuperata definizione di città di uno dei pensatori più influenti del Novecento, Claude Lévi-Strauss.
L’interesse di Italo Calvino per i fenomeni urbani non è estemporaneo, ma attraversa tutta la sua produzione letteraria, nella saggistica così come nella letteratura. Il suo interesse per la «cosa umana per eccellenza», insuperata definizione di città di uno dei pensatori più influenti del Novecento, Claude Lévi-Strauss, [1] viene da lontano, dall’inizio degli anni Sessanta e si sviluppa anche grazie ad un gruppo di amici intellettuali che frequentano lo stesso ritrovo estivo di Bocca di Magra, piccolo paese di pescatori al confine tra Liguria e Toscana. Qui Calvino è tra i soci di una fondazione, Società degli Amici di Bocca di Magra, che si batte contro gli interessi speculativi di gruppi finanziari che voglio urbanizzare questa parte della costa tirrenica, allora la meno mondana della Versilia e di tutta la riviera ligure, per «favorire un più ordinato sviluppo economico e sociale di questa parte del nostro paese». [2]
Di questa fondazione fanno parte Giulio Einaudi, Luigi Biso, Nicola Chiaromonte, Franco Fortini, Giorgio Piccardi, Vittorio Sereni, Valentino Bompiani, Guido Piovene, Mario Soldati, Elio Vittorini, Hans Deichmann, Vittorio Korach e molti altri ancora. Tra questi anche Luciano Bianciardi che dedica a Vittorio Sereni, Italo Calvino e agli amici di Bocca di Magra questa filastrocca.
«Orsù amici! In folta schiera difendiamo la scogliera. Osteggiamo con furore il venal speculatore che lottizza, taglia e sparte. Via la pista del gocarte! Combattiamo con dispetto il tetragono architetto. Difendiamo da ogni male l’habitatte naturale. Così bello ricco e vario del periodo quaternario. Aspra ed erta fia la strada ma agguerrita è la masnada. Della sana intellighenzia (Storia e Musa ed Arte e Scienza!) Chè sovvengon da Torino sia l’Einaudi che il Calvino. Vien Milano a ranghi pieni col Fortini e col Sereni. Col De Carlo e col Bianciardi arrivato un poco tardi. Da Trieste si fa sotto il Gambino 48. Vittorini in spirto v’è pur se estata a Santropè. Siano i dubbi inascoltati dello scettico Soldati. Siamo noi i soldati veri menti elette e cuor sinceri. Orsù amici, chè a noi tocca di difendere la Bocca». [3]
Spirito goliardico che non impedisce a Calvino di affrontare, approfondire e discutere le questioni urbane in un consesso che tiene insieme, come nella migliore tradizione della cultura classica, diverse discipline: poesia, letteratura, architettura, pittura, scultura. In questo contesto la discussione sui fenomeni urbani è più serrata con Giancarlo De Carlo ed Elio Vittorini, ai quali si unisce, spesso, Vittorio Sereni.
Calvino, Vittorini e De Carlo daranno vita a tre libri che hanno come tema centrale proprio la città. Elio Vittorini pubblicherà Le città del mondo, uscito dopo la sua morte nel 1969, Italo Calvino, Le città invisibili nel 1972 e Giancarlo De Carlo nel 1995, Nelle città del mondo. Libri che esprimono punti di vi-sta diversi sulla città e i fenomeni urbani, frutto di elaborazioni teoriche e culturali di tre autori molto diversi tra loro: un narratore, un sognatore e un progettista.
A Calvino si deve il titolo del libro di Elio Vittorini, Le città del mondo. Interpellato dalla moglie dello stesso Vittorini, Ginetta, – che Vittorini aveva sposato ufficialmente alcuni giorni prima della sua morte – insistette perché il titolo del romanzo, postumo, contenesse il termine città proprio in relazione a quell’interesse comune che li aveva visti discutere, anche animatamente, nel corso degli anni. Vittorini in questo romanzo esprime, da un punto di vista progettuale, «progetto, prospettiva, indicazione sono parole-chiave del discorso di Vittorini. Tutto il suo lavoro – creativo, critico, editoriale – ha intenzione e funzione di programma, di manifesto», [4] in relazione al romanzo e alla stessa letteratura, un desiderio di bellezza che trova il suo appagamento proprio nella città, sognata e agognata dai personaggi del romanzo. Il desiderio di bellezza Vittorini si trasforma e diventa ricerca di bellezza attraverso il progetto urbano e di architettura nel libro di Giancarlo De Carlo, «Italo Calvino era venuto a Urbino e aveva dormito al Collegio del Colle. Gli avevo chiesto, la mattina dopo, come si era trovato in quell’ambiente un po’ particolare. E lui mi aveva detto che tutto gli era molto piaciuto, ma quello che gli era piaciuto di più era stato che in quel Collegio uno potrebbe uscire al mattino perché deve incontrare una ragazza che gli piace. E allora comincia a seguire un percorso; però, a un certo punto, il percorso si dirama e poi si dirama ancora, e sale e scende e va in obliquo e offre sempre più scelte; finché arrivi a un ultimo incrocio dove incontri un’altra ragazza che ti piace ancora di più e ti dimentichi della prima: la tua vita cambia e la causa e? l’architettura». [5]
A differenza dei primi due, nel libro delle città immaginate da Calvino queste ultime prefigurano un mondo irreale che gli uomini non potranno mai abitare, anche per questa ragione persiste e prevale su tutto, il sentimento del desiderio, «l’ostinata ricerca di un fare letterario che attraverso i propri mezzi speci-fici mantenga attiva dentro l’essere umano la facoltà di pensare e rappresenta-re la propria felicità». [6]
Calvino è attento osservatore delle trasformazioni urbane soprattutto negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale quando furono ricostruite città in gran numero perché distrutte, in alcuni casi rase al suolo dai bombardamenti e solo per restare in Italia, «i bombardamenti sulle città italiane iniziarono l’11 giugno 1940, circa 24 ore dopo la dichiarazione di guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, mentre le ultime bombe caddero all’inizio di maggio 1945 sulle truppe tedesche in ritirata verso il Brennero. Nei cinque anni che passarono tra queste due date, quasi ogni città italiana fu bombardata». [7] Trasformazioni urbane che nelle loro evoluzioni prendono forma attingendo da tutte le discipline artistiche e culturali, in perfetta e totale sintonia con il sentire comune della produzione intellettuale di quegli anni. Il metaprogetto prima dell’approfondimento, il concetto generale prima del particolare, l’analisi prima del progetto. In questo senso anche Calvino è un progettista, di romanzi innanzitutto, ma parimenti di idee di città, al pari di Giancarlo De Carlo o di Aldo Rossi, entrambi architetti.
«Nell’opera di Calvino le città sono numerose, anche prima del libro del 1972 (Le città invisibili, ndr). I dati che più ci interessano sono due. Innanzi tutto, nelle città intese come scenario urbano della storia i personaggi calviniani risultano spesso appena arrivati: si vedano La formica argentina, Marcovaldo, La nuvola di smog. Un’eccezione che conferma la regola è La speculazione edilizia, dove si parla di una città natale che sta diventando sempre più irriconoscibile. E infatti sia Marco Polo sia l’imperatore Kublai Kan, rispetto alle cinquantacinque città descritte nelle Città invisibili, sono stranieri. In secondo luogo, anche il tema della città che appare tale solo a chi abbia occhi per riconoscerla è anticipato in opere precedenti: si pensi alla città dei gatti della novella di Marcovaldo, o all’inattesa intuizione utopica che illumina il finale della Giornata di uno scrutatore, resoconto di un’esperienza all’interno di una struttura chiusa grande come un quartiere (“quasi una città nella città”): “Anche l’ultima città dell’imperfezione ha la sua ora perfetta, pensò lo scrutatore, l’ora, l’attimo, in cui in ogni città c’è la Città». [8]
Nel costruire i suoi romanzi, Calvino, pensa e utilizza preferibilmente paesaggi, «bisogna subito dire che mentre io scorro quel paesaggio per descriverlo come risulta dai diversi punti del suo spazio, naturalmente è anche nel tempo che scorro, cioè, descrivo il paesaggio come risulta nei diversi momenti del tempo che impiego spostandomi. Perciò una descrizione di paesaggio, essendo carica di temporalità, è sempre racconto: c’è un io in movimento che descrive un paesaggio in movimento, e ogni elemento del paesaggio è carico di una sua temporalità cioè della possibilità d’essere descritto in un altro momento presente o futuro», [9] spazi urbani più che singole architetture. Alla stregua di un architetto persegue e colloca la forma di ognuna delle sue invisibili città alla fine di un processo e di un percorso progettuale. In questo sembra aver introiettato proprio la lezione di Aldo Rossi, uno dei padri fondatori del filone culturale architettonico che andrà sotto il nome di Tendenza e che rappresenta nel corso degli anni Sessanta e Settanta uno dei riferimenti italiani nella cultura architettonica mondiale e che ne L’Architettura della città scrive: «La città, oggetto di questo libro, viene qui intesa come una architettura. Parlando di architettura non intendo rifermi solo all’immagine visibile della città e all’insieme delle sue architetture, ma piuttosto all’architettura come costruzione. Mi riferisco alla costruzione della città nel tempo […] col tempo la città cresce su stessa; essa acquista coscienza e memoria di sé stessa. Nella sua costruzione permangono i motivi originari, ma nel contempo la città precisa e modifica i motivi del proprio sviluppo […] L’architettura è la scena fissa delle vicende dell’uomo carica di sentimenti di generazioni, di eventi pubblici, di tragedie private, di fatti nuovi e antichi […] Noi possiamo studiare la città da molti punti di vista: ma essa emerge in modo autonomo quando la consideriamo come dato ultimo, come costruzione, come architettura. In altri termini, quando analizziamo i fatti urbani per quello che essi sono, come costruzione ultima di una elaborazione complessa; tenendo conto di tutti i dati di questa elaborazione che non possono essere compresi nella storia dell’architettura, né dalla sociologia, né da altre scienze. Sono propenso a credere che la scienza urbana, intesa in questo modo, possa costituire un capitolo della storia della cultura, e per il suo carattere complessivo uno dei capitoli principali». [10]
L’architettura sono le architetture sostiene Aldo Rossi e se la città è intesa come architettura, come costruzione, la città non può essere altro che questo. Un concetto che sta a cuore anche a Calvino che fa dire al suo Marco Polo ne Le città invisibili, «Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. Eppure tra l’una e l’altro c’è un rapporto […] La menzogna non è nel discorso, è nelle cose». [11]
Aldo Rossi analizza i rapporti esistenti tra tipologia edilizia e morfologia urbana, ovvero lo studio dei tipi edilizi e della forma della città in una relazione che definisce binaria. Scrive l’architetto milanese, «Ho sempre affermato che i luoghi sono più forti delle persone, la scena fissa è più forte della vicenda. Questa è la base teorica non della mia architettura ma dell’architettura; in sostanza è una possibilità di vivere». [12]
E sul concetto di architettura come scena fissa, emergono affinità, correspondances, tra ciò che scrive Aldo Rossi e ciò che scrive Italo Calvino in uno dei testi preparatori per le Norton Lectures del 22 febbraio 1985. «Nel teatro antico, la scena fissa rappresenta il luogo ideale in cui tutte le tragedie così come tutte le commedie possono svolgersi. Un luogo della mente, fuori dello spazio e del tempo, ma tale da identificarsi con i luoghi ed i tempi d’ogni azione drammatica. I teatri romani che si sono conservati e le ricostruzioni del Rinascimento palladiano ci hanno reso familiare quest’immagine della classicità come possibilità impassibile allo scatenarsi delle passioni umane: la facciata marmorea d’un solenne palazzo con la porta reale al centro e le due porte più piccole simmetriche ai lati, che poteva essere ogni reggia, ogni tempio, ogni piazza di città. Bastava che dalla soglia d’una di quelle porte si affacciasse un re, o un indovino, o un messaggero, ed ecco che tra le tante azioni potenziali una diventava attuale, senza che la continuità con il resto dell’esistente e dell’immaginabile fosse spezzata». [13]
Su questo punto specifico, la ricerca dell’architetto e teorico dell’architettura, Aldo Rossi, e quella del letterato e romanziere, Italo Calvino, sembra correre parallela. La connessione che li tiene insieme è il pensiero progettuale che prende le mosse dalle stesse considerazioni generali: la forma, sia essa quella di un romanzo piuttosto che di un paesaggio o un’architettura, è il risultato finale e non la premessa e il riferimento per la redazione di un progetto e passa attraverso l’analisi, il riconoscimento e il disvelamento della scena fissa, lo spartito sul quale scrivere una nuova storia, nuove storie.
Sul concetto di scena fissa emergono affinità non solo con l’architettura ma con tante altre discipline, come il cinema per esempio. Un altro grande progettista, in questo caso di immagini in movimento, è il regista tedesco Wim Wenders che scrive a questo proposito, «Una strada, una fila di case, una montagna, un ponte, un fiume sono per me qualcosa di più un semplice sfondo. Possiedono infatti una storia, una personalità, un’identità che deve essere presa sul serio; e influenzano il carattere degli uomini che vivono in quell’ambiente, evocano un’atmosfera, un sentimento del tempo, una particolare emozione. Possono essere brutti, belli, vecchi, giovani; ma sono comunque elementi presenti, e per un attore è proprio l’unica cosa che conti: Quindi meritano di esser presi sul serio». [14]
Corrispondenze multiple dunque che Alberto Ferlenga, architetto e allievo di Aldo Rossi, sottolinea in occasione di una mostra antologica organizzata dalla Triennale di Milano nel 2002, trentesimo anniversario dell’uscita de Le Città invisibili, «I due testi, (si riferisce a L’Architettura della città e Le Città Invisibili, ndr) versante scientifico e letterario di un’attenzione alla città e alla storia a lungo riconosciuta come specificità dell’architettura italiana, sono legati da molti fili. Immaginati come schizzo, come frammento da continuare, male utilizzati e fraintesi proprio in un ambito, quello degli architetti, che più avrebbe dovuto riconoscerne il valore di strumento aperto, essi hanno conosciuto, nell’ordine: un amore maniacale, un uso dissennato e un rifiuto precoce. Per anni meno frequentati ci si presentano oggi come dotati di una nuova verginità, provvisti, potremmo dire, di un nuovo valore d’uso, passata l’ubriacatura che ne aveva determinato il rifiuto ma soprattutto cambiato il punto di vista e la consapevolezza di chi oggi li legge. E di entrambi i libri riemerge la natura aperta, il loro essere soprattutto geniali intuizioni di un percorso, veri strumenti di lavoro, generatori di radici sotterranee che riemergono inaspettatamente in ogni dove, sotto forma di ricerche, progetti e conoscenze». [15]
Il libro di Aldo Rossi, L’architettura della città, pubblicato nel 1966, s’inserisce nel dibattito europeo sulla nascita del progetto urbano e continua ad avere, a quasi sessant’anni della sua prima pubblicazione, un grande riscontro e suc-cesso nelle università di tutto il mondo.
Nove anni dopo la pubblicazione del libro di Aldo Rossi, in un testo pubblicato su Nuova Società dal titolo Gli dei della città, siamo nel 1975, Calvino scrive: «[…] città diverse si succedono e si sovrappongono sotto uno stesso nome di città, occorre non perdere di vista quale è stato l’elemento di continuità che la città ha perpetuato lungo tutta la sua storia, quello che l’ha distinta dalle altre città e le ha dato un senso. Ogni città ha un suo “programma” implicito che deve saper ritrovare ogni volta che lo perde di vista, pena l’estinzione […] Una città può passare attraverso catastrofi e medioevi, vedere stirpi diverse succedersi nelle sue case, veder cambiare le sue case pietra per pietra, ma deve, al momento giusto, sotto forme diverse, ritrovare i suoi dei». [16]
Più che concentrarsi sulla configurazione formale del progetto urbano o sul singolo progetto di architettura o di paesaggio, Calvino pone l’attenzione su ciò che sta prima del progetto e sul genius loci, e, ancora una volta, il pensiero corre ad Aldo Rossi che sempre ne L’Architettura della città aveva posto l’attenzione su questo stesso tema, «La scelta del luogo per una costruzione singola come per una città, aveva un valore preminente nel mondo classico; la “situazione”, il sito, era governato dal “genius loci”, dalla divinità locale, una divinità appunto di tipo intermedio che presiedeva a quanto si svolgeva in questo stesso luogo […] questa nozione del luogo e del tempo sembra inesprimibile razionalmente anche se essa comprende una serie di valori che “sono” al di fuori e oltre i sentimenti che noi proviamo nel coglierli […] i le-gami e la precisazione stessa del “locus” come un fatto singolare determinato dallo spazio e dal tempo, dalla sua dimensione topografica e dalla sua forma, dall’essere sede di vicende antiche e nuove, dalla sua memoria». [17]
Rimandi continui, limature di pensiero che testimoniano di un tempo e di modalità comuni di affrontare le questioni collettive come sono, appunto, le questioni che riguardano la città. Aldo Rossi aveva scritto, «L’architettura è la scena fissa delle vicende dell’uomo; carica di sentimenti di generazioni, di eventi pubblici, di tragedie private, di fatti nuovi e antichi», e Calvino nella conferenza del 29 marzo del 1983, rivolgendosi agli studenti della Graduate Writing Division della Columbia University di New York, nel presentare Le città invisibili così propone il concetto di città: «Che cosa è oggi la città, per noi? Penso di aver scritto qualcosa come un ultimo poema d’amore alle città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città. Forse stiamo avvicinandoci a un momento di crisi della vita urbana, e Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. Oggi si parla con eguale insistenza della distruzione dell’ambiente naturale quanto della fragilità dei grandi sistemi tecnologici che può produrre guasti a catena, paralizzando metropoli intere. La crisi della città troppo grande è l’altra faccia della crisi della natura […] Quello che sta a cuore al mio Marco Polo è scoprire le ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, ragioni che potranno valere al di là di tutte le crisi. Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Il mio libro s’apre e chiude su immagini di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici». [18]
Qualche anno più tardi, in un quella che sembra essere una corrispondenza di urbani sensi, Aldo Rossi sembra quasi rispondere a Calvino quando scrive, «L’architettura era uno dei modi di sopravvivere che l’umanità aveva ricercato; era un modo di esprimere la sua fondamentale ricerca della felicità». [19]. Ancora una volta dunque, affinità, correspondences, idem sentire. Ricerca della felicità attraverso la costruzione della città nel tempo, «La forma della città è sempre la forma di un tempo della città; ed esistono molti tempi nella forma della città. Nel corso stesso della vita di un uomo la città muta volto attorno a lui, i riferimenti non sono gli stessi», [20] e di rimando «Così viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma». [21]
Costruzione nel tempo e vivibilità della città associata alla felicità, sono temi che si ripropongono ciclicamente nella storia della costruzione della città, attraverso, per esempio, la ricerca e lo studio sulla città ideale che in relazione al periodo storico-culturale in cui è declinata assume diverse configurazioni: metafora della Torre di Babele, Città ideale rinascimentale o la radicale Archigram City del 1960.
La Torre di Babele, già contenuta nel libro della Genesi, fu costruita da un popolo che utilizzava una sola lingua e che dominava la Terra con lo scopo di elevarsi fino a Dio proprio alla ricerca della felicità totale e compiuta. La Città ideale, opera rinascimentale, è un dipinto che si può datare tra il 1480 e il 1490 ed è conservato nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino. Considerata una delle immagini simbolo del Rinascimento italiano è stata attribuita a molti artisti, tra questi Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini, Leon Battista Alberti. Archigram City è invece una rappresentazione più vicina al nostro tempo e trae ispirazione dalla tecnologia per proporre idee di città tra loro complementari, Plug-in-City, The Walking City, Instant City, Tuned City.
Città felici nascoste nelle città infelici, città invivibili come le megalopoli «e del dissolversi della sua forma comprensibile, almeno secondo i criteri di giudizio e le categorie che per secoli avevano permesso di raccontarla», [22] ricerca delle ragioni che spingono le persone ad abbandonare tutto ciò che non è urbano per trasferirsi nelle città, sono alcune delle questioni che Calvino si pone e sulle quali s’interroga. Anche per questa ragione, Le città invisibili lo si può considerare un libro politico. Perché attraverso la descrizione e il profilo delle sue città invisibili, immaginate, sognate, evocate, denuncia le problematiche dell’età contemporanea: perdita dell’identità dei luoghi dovuta in primo luogo ad un’espansione urbana senza più limiti, uso indiscriminato del suolo pubblico, consumismo. Crea città per interrogarle con la stessa pervicacia con cui Kublai Khan interroga Marco Polo, entrambi, Calvino e Khan, alla ricerca continua e perenne di sé stessi.
Città, «non sono altro che la forma del tempo», [23] e dinamiche urbane si manifestano in modo più evidente che altrove né Le città invisibili. Lo scrive lo stesso Calvino nel capitolo Esattezza di Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. «Un simbolo più complesso, che mi ha dato le maggiori possibilità di esprimere la tensione tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane è quello della città. Il mio libro in cui credo d’aver detto più cose, resta Le città invisibili, perché ho potuto concentrare su un unico simbolo tutte le mie riflessioni, le mie esperienze, le mie congetture; e perché ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta vicino agli altri in una successione che non implica una consequenzialità o una gerarchia ma una rete entro la quale si possono tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate». [24]
E mentre Calvino prepara le Norton Lectures che avrebbe dovuto tenere all’Università di Harvard nell’anno accademico 1985-86, e scrive dunque il passo appena citato, Giancarlo De Carlo che non poteva essere a conoscenza di questo testo che sarà pubblicato soltanto nel 1988, scrive nello stesso anno un memorabile editoriale nella rivista Spazio e Società, «Italo Calvino con Le città invisibili ha scritto il più bel libro di architettura e urbanistica che sia uscito negli ultimi cinquant’anni. Gli studenti di architettura e gli architetti che continueranno a leggerlo negli anni futuri ricorderanno con ammirazione, affetto e riconoscenza il suo prodigioso autore». [25]
Un riconoscimento e un tributo che arriva direttamente da uno dei più influenti architetti del Novecento italiano.
È evidente che ne Le città invisibili «da quel vero architetto che è, si appassiona e si danna a disegnare strutture sempre più complesse, elenchi sempre più tormentati, irti di cancellazioni e frecce e inversioni, alla rincorsa dell’ordine ideale» [26] da contrapporre al caos per determinare un senso compiuto alle cose e governare la complessità. Una continua ricerca di spazi di libertà come estrema e ultima difesa da opporre all’avanzata dell’omologazione e alle contraddizioni della contemporaneità.
La terza delle Lezioni americane, intitolata Esattezza, sembra essere stata scritta da un teorico dell’architettura piuttosto che da un romanziere, da un baumeister, un costruttore come direbbero i tedeschi. «Cercherò prima di tutto di definire il mio tema. Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose: 1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, “icastico”, dal greco ??????????; 3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero dell’immaginazione». [27]
E più avanti per esplicitare meglio questo concetto si addentra in questioni legate alla forma, trattandole con una perizia e padronanza del tema che rendono più evidente la sua preparazione e maturazione sul tema, vieppiù la qualità derivante dalle sue frequentazioni con professionisti e artisti di tante discipline diverse e una volta ancora affiorano corrispondenze. «Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze […] Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste. Anche le immagini, per esempio […] immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma come significato, come forza d’imporsi all’attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola d’immagini si dissolve immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria; ma non si dissolve una sensazione d’estraneità e di disagio […] Il mio disagio è per la perdita di forma che constato nella vita, e a cui cerco d’opporre l’unica difesa che riesco a concepire: un’idea della letteratura». [28]
In questo caso la riflessione ha molti punti di contatto con l’architettura ma non solo, con il cinema per esempio, e, ancora una volta, con il regista tedesco Wim Wenders. «Nel mestiere del regista si cela il pericolo di produrre immagini fini a se stesse, e dai miei stessi errori ho imparato che “una bella immagine” non ha alcun valore in sé, al contrario: una bella immagine può distruggere l’effetto e il funzionamento dell’intera struttura drammatica. Quando iniziai a fare cinema, se il pubblico lodava le mie immagini mi ritenevo certamente lusingato, come se fosse il miglior plauso. Oggi, se qualcuno le loda penso piuttosto di aver sbagliato qualcosa nel film. E dai miei sbagli ho imparato che l’unico antidoto contro le immagini autocelebrative è credere fermamente alla priorità della storia. Ogni immagine trae infatti una sua legittimità solo in rapporto a un personaggio della storia che narra; e dandole troppa importanza finisce per indebolire il personaggio. E una storia con personaggi deboli non ha alcuna forza. Solo la storia, l’insieme dei personaggi conferisce credibilità a ogni singolo fotogramma, “fonda una morale”, per esprimermi nel gergo di un artista». [29]
Anche in questo concetto espresso dal regista tedesco torna in modo preponderante il tema della scena fissa, l’ordito sul quale costruire il film, la narrazione, l’idea di città.
Città che permane al centro dei suoi interessi che coltiva anche con Giorgio De Chirico, Cesare Peverelli, Fabio Borbottoni, Fausto Melotti, personalità artistiche rilevanti del panorama italiano e internazionale.
Scrive Mario Barenghi, «L’incontro fra Calvino e Giorgio de Chirico non può che avvenire sul terreno delle città. L’occasione è una mostra che si tiene al Centro Pompidou nel 1983. Come in altri casi di testi legati a esposizioni d’arte, Calvino opta per un impianto narrativo, ma il racconto trasloca nel saggio. Il Viaggio nelle città di De Chirico conduce molto lontano dall’atmosfera delle Città invisibili (“Qui tutto è esatto, definitivo, stabile: quel che c’è c’è e, per strano che sia, non potrebbe essere altrimenti”); ma il geometrico nitore delle forme suggerisce uno slittamento dallo sguardo, cioè dal pensiero, alla visione e al sogno». [30]
E se è vero che, come scrive Calvino, nelle tele di De Chirico tutto è esatto, definitivo, stabile e dunque lontano dalle atmosfere delle sue città invisibili, è altrettanto vero che in alcuni passaggi della conferenza tenuta al Centre Georges Pompidou a Parigi, il 9 marzo 1983, lo stesso Calvino sembra riflettere e riferire direttamente al lettore di città alle quali sta pensando, nuovi orizzonti di scrittura che potrebbero abitare e popolare nuove esperienze letterarie.
«Questa città è fatta per accogliere il pensiero, per contenerlo e trattenerlo senza che si senta costretto. Qui il pensiero trova il suo spazio, e il suo tempo, un tempo sospeso, come d’invito, d’attesa. Qui il pensiero sente d’essere sul punto d’affacciarsi all’orizzonte della mente, e può prolungare questo stato d’incertezza aurorale e rimandare il momento in cui sarà obbligato a precisarsi, a diventare il pensiero di qualcosa […] La città del pensiero non suggerisce pensieri d’una specie o d’un’altra, né obbliga a riflettere sulle apparizioni e gli incontri che in essa occorrono, o a indagare i suoi misteri. Luce, ombra, facciate, monumenti, esseri, oggetti vi sono disposti in modo da distogliere la mente da emozioni e passioni e condizionamenti esteriori. Da quel momento il pensiero, rimosso, rimossi tutti gli ostacoli, può partire in ogni direzione, con passi ora fulminei ora lentissimi». [31]
Un romanziere che, quando scrive di città, nella saggista come nella letteratura, utilizza spazi urbani più che singoli manufatti e anche quando si sofferma su singole costruzioni, queste sono sempre inserite in contesti descrittivi più ampi, di respiro territoriale. E se fino alla fine degli anni Settanta scrivere e intervenire nel dibattito pubblico sulla città e gli spazi urbani così come sull’architettura vedeva Calvino protagonista in prima persona con architetti, urbanisti e artisti, oltre che con scrittori ovviamente, a partire dagli anni Ottanta e dopo la morte che lo coglie a Santa Maria della Scala il 19 settembre del 1985, i suoi scritti diventano un riferimento costante e imprescindibile per una nuova generazione di progettisti, architetti e urbanisti innanzitutto. La cultura architettonica italiana continua ad attingere a piene mani da Calvino e da due suoi libri in modo particolare: Le città invisibili e Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio.
E come scrivono Marco Biraghi e Silvia Micheli, «se nel caso del primo (libro n.d.r.) la quantità dei rimandi, benché spesso pretestuosi, poteva lasciarsi spiegare sulla base di ragioni meramente “tematiche”, nel caso del secondo presupponeva invece l’esistenza di una corrispondenza, di un “piano analogico” tra letteratura e architettura: un’analogia certo non impossibile o impensabile, e tuttavia ben lungi dall’essere verificata […] Va presa in ogni caso come un’indicazione degna di nota che “leggerezza”, “rapidità”, “esattezza”, “visibilità” e “molteplicità” siano stati più o meno implicitamente assunti come obiettivi condivisibili per il “prossimo millennio”, anche dalla cultura architettonica contemporanea italiana». [32]
Il libro che possiamo considerare il suo testamento, «Lezioni Americane, nelle quali Calvino ha condensato tutta la sua esperienza e tutte le sue convinzioni» [33] e anche l’ultimo scritto da Italo Calvino e se è vero che leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità sono stati assunti come obiettivi condivisibili da una nuova generazione di progettisti e altresì vero che la loro forza evocativa non si esaurisce solo in questo. Un’esortazione continua a guardare alla città come ad un riferimento imprescindibile per gli uomini e le donne che abitano il pianeta Terra è uno stimolo continuo per continuare ad indagare, studiare, conoscere.
«Le città» – come sostiene Wim Wenders – «non raccontano storie, ma possono comunicarci qualcosa sulla Storia; possono conservare e mostrare la loro storia, renderla visibile oppure nasconderla. Possono aprire gli occhi, come succede nei film, o chiuderli. Possono divorare o nutrire la fantasia». [34]
Guardare per comprendere e capire, per cogliere il senso più profondo delle cose. Cercare e ricercare le ragioni che spingono gli uomini a vivere nelle città. «Le città hanno sempre suscitato l’interesse di Calvino, perché sono un’immagine di vita associata, dentro la quale è possibile preservare la propria individualità. Sono come la tana immaginaria dei ragni. Sappiamo adesso che, quando Calvino attraversava la deserta Torino del dopoguerra, esercitandosi nell’arte della diagonalità, era già alla ricerca delle possibili città invisibili implicite nei lunghi viali che si perdono in un infinito nebbioso». [35]
L’influenza e la presenza di Italo Calvino nella cultura architettonica italiana è grande e diffusa per alcune delle ragioni esposte, ovvero per la poliedricità dell’intellettuale italiano nato a Cuba, cresciuto a Sanremo e poi a Torino, Parigi, Roma. Ma la motivazione principale per cui la sua influenza su architetti, urbanisti, artisti, resterà tale è la passione e competenza sviluppata su tutto ciò che riguarda le questioni urbane e il sogno coltivato e alimentato per tutta la vita di una città vivibile e felice.
La città è il luogo, più che ogni altro posto immaginabile, dove è possibile l’integrazione sociale e culturale. Il luogo dove è più facile per l’essere umano entrare in contatto con un altro essere umano. È il luogo di «un processo di continua ibridazione produttore di nuove identità, di nuovi soggetti e di nuove idee». [36] Per estensione e ricorrendo a Marc Augé, potremmo dire che «la vita politica ed economica del pianeta dipende dai centri decisionali situati nelle grandi metropoli mondiali, tutte interconnesse fra loro al punto da costruire nel loro complesso una sorta di “metacittà virtuale” (Paul Virilio). Il mondo è un’immensa città. È un mondo-città». [37]
Per tutte queste ragioni l’interesse di Italo Calvino per i fenomeni urbani non è stato estemporaneo, ma ha attraversato tutta la sua produzione letteraria. Per queste ragioni ha molto amato le riflessioni di Claude Lévi-Strauss e in particolare la sua attenzione nei confronti della città che in Tristi Tropici ci regala la più bella definizione di città, «Non è in senso metaforico che si ha il diritto di confrontare una città a una sinfonia o a un poema; sono infatti oggetti della stessa natura. Più preziosa ancora, forse, la città si pone alla confluenza della natura con l’artificio […] la città, per la sua genesi e per la sua forma, risulta contemporaneamente dalla processione biologica, dalla evoluzione organica e dalla creazione estetica. Essa è, nello stesso tempo, oggetto di natura e soggetto di cultura; individuo e gruppo; vissuta e sognata; cosa umana per eccellenza». [38]
[1] Claude Lévi-Strauss, “Tristi Tropici”, ilSaggiatore Milano, p. 108, 2015.
[2] www.italianostra.org Dossier In “alluvioni in Lunigiana”, Ottobre 26, 2011|Apuo Lunen-se, Dossier, Toscana.
[3] www.italianostra.org, Dossier IN “Alluvioni in Lunigiana”, Ott 26, 2011|Apuo Lunense, Dossier, Toscana.
[4] Italo Calvino, “Progettazione e letteratura”, in il menabò 10, Einaudi, Torino, 1967.
[5] Franco Bunc?uga, “Conversazioni con Giancarlo De Carlo”, Elèuthera, Milano, 2000
[6] Francesca Rubini, “Romanzi e racconti, Le città invisibili in A Z Calvino”, a cura di Marco Belpoliti, Electa, Milano, p. 77, 2023.
[7] Claudia Baldoli, “I bombardamenti sull’Italia nella Seconda Guerra Mondiale”, DEP, De-portate, esuli, profughe, Rivista telematica di studi della memoria femminile. Questa ricerca fa parte di un progetto comparato sull’impatto dei bombardamenti in Europa occidentale (1940-45), ISSN 1824-4483.
[8] Mario Barenghi, “Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte: Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri”, Electa, Milano, p. 33, 2023.
[9] Italo Calvino, “Ipotesi di descrizione di un paesaggio”, in “Italo Calvino. Guardare. Dise-gno, cinema, fotografia, arte, paesaggio, visioni e collezioni”. Mondadori, Milano, p. 471, 2023.
[10] Aldo Rossi, “L’architettura della città”, Clup, Milano, pp. 12-13-14, 1978.
[11] Italo Calvino, “Le città invisibili”, Einaudi, Torino, pp. 67-68, 1972.
[12] Aldo Rossi, “Autobiografia scientifica”, Pratiche edizioni, Parma, p. 63, 1990.
[13] Italo Calvino, “Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio”, Oscar Mon-dadori, Milano, p.125, 2015.
[14] Wim Wenders, “The Urban Landascape”, In Wim Wenders, “L’atto di vedere. The act of seeing”, Ubulibri Milano, p. 89, 1992. Wenders si rivolge a un pubblico di architetti riuniti in un convegno a Tokyo il 12 ottobre 1991.
[15] Alberto Ferlenga, “Invisibili profondità” in “La visione dell’invisibile. Saggi e materiali su Le città invisibili di Italo Calvino”, Mondadori, Milano, p.144, 2002.
[16] “Nuova società”, n.67, 15 novembre 1975. Intervento in un’inchiesta pubblicata succes-sivamente in volume: “Com’è bella la città”, Stampatori, Torino 1977
[17] Aldo Rossi, “L’architettura della città”, Clup, Milano, pp. 135-135-140, 1984.
[18] Italo Calvino, “Le città invisibili”, Oscar Mondadori, Milano, pp. IX-X, 2001
[19] Aldo Rossi, “Autobiografia scientifica”, Pratiche Editrice, Parma, pp. 9-10, 1990.
[20] Aldo Rossi, “L’architettura della città”, Clup, Milano, p. 57, 1978.
[21] Italo Calvino, “Le città invisibili”, Einaudi, Torino, p. 82, 1972.
[22] Alberto Ferlenga, “Invisibili profondità” in “La visione dell’invisibile. Saggi e materiali su Le città invisibili di Italo Calvino”, Mondadori, Milano, p. 140, 2002.
[23] Conversazione con Michele Neri in Panorama mese, IV, 1, gennaio 1985
[24] Italo Calvino, “Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio”, Oscar Mon-dadori, Milano, p. 72, 2015.
[25] Giancarlo De Carlo, Editoriale, in “Spazio e Società – Space & Society” n. 31-32, settem-bre-dicembre, pp. 6-7, 1985.
[26] Ernesto Ferrero, “Italo”, Einaudi, Torino, p.163, 2023.
[27] Italo Calvino, “Lezioni americane. Sei lezioni per il nuovo millennio”. Oscar Mondadori, Milano, pp. 59-60, 2015.
[28] Italo Calvino, “Lezioni americane. Sei lezioni per il nuovo millennio”. Oscar Mondadori, Milano, pp. 60-61, 2015.
[29] Wim Wenders, “The Urban Landascape”. Wenders si rivolge a un pubblico di architetti riuniti in un convegno a Tokyo il 12 ottobre 1991, in Wim Wenders, “L’atto di vedere. The act of seeing”, Ubulibri Milano, p. 89, 1992.
[30] Mario Barenghi, “Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte: Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri”. Electa, Milano, p. 172, 2023.
[31] Marco Belpoliti, “Italo Calvino, Guardare. Disegno cinema, fotografia, arte, paesaggio, vi-sioni e collezioni”, Mondadori, Milano, pp. 387-388, 2023.
[32] Marco Biraghi, Silvia Micheli, “Storia dell’architettura italiana 1985-2015”, Einaudi, Tori-no, p. XVII, 2013.
[33] Jean Starobinski, “Le opere di Italo Calvino. Romanzi e racconti nei Meridiani” Meridiani Mondadori volume primo, Milano, pagina XII, 1991.
[34] Wim Wenders, “The Urban Landascape”. Wenders si rivolge a un pubblico di architetti riuniti in un convegno a Tokyo il 12 ottobre 1991. In Wim Wenders, “L’atto di vedere. The act of seeing”, Ubulibri Milano, p. 91, 1992.
[35] Silvio Perrella, “Calvino”, Editori Laterza, Roma, p.126, 2023.
[36] Bernardo Secchi, “La città dei ricchi e la città dei poveri”, Editori Laterza, Bari, p. 3, 2013.
[37] Marc Augé, “non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità”, elèuthera Milano, p.12, 1993.
[38] Claude Lévi-Strauss, “Tristi Tropici”, il Saggiatore, Milano, p. 108, 2015.

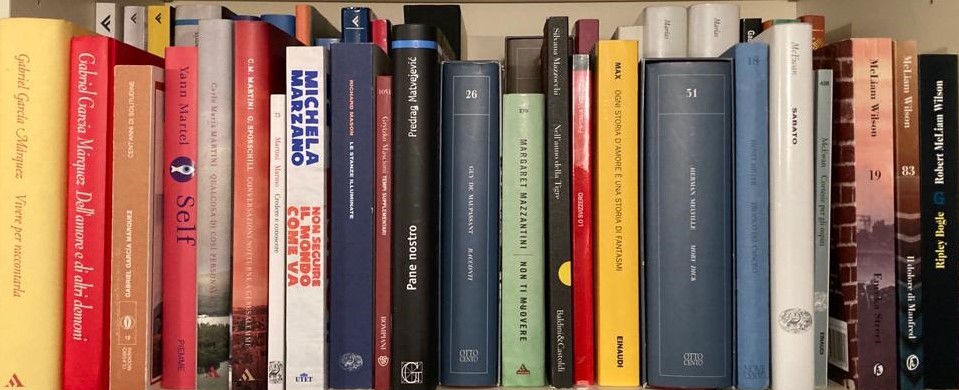
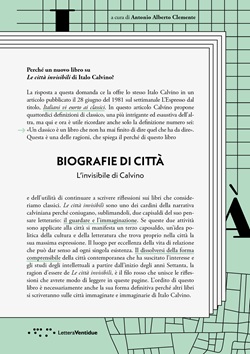
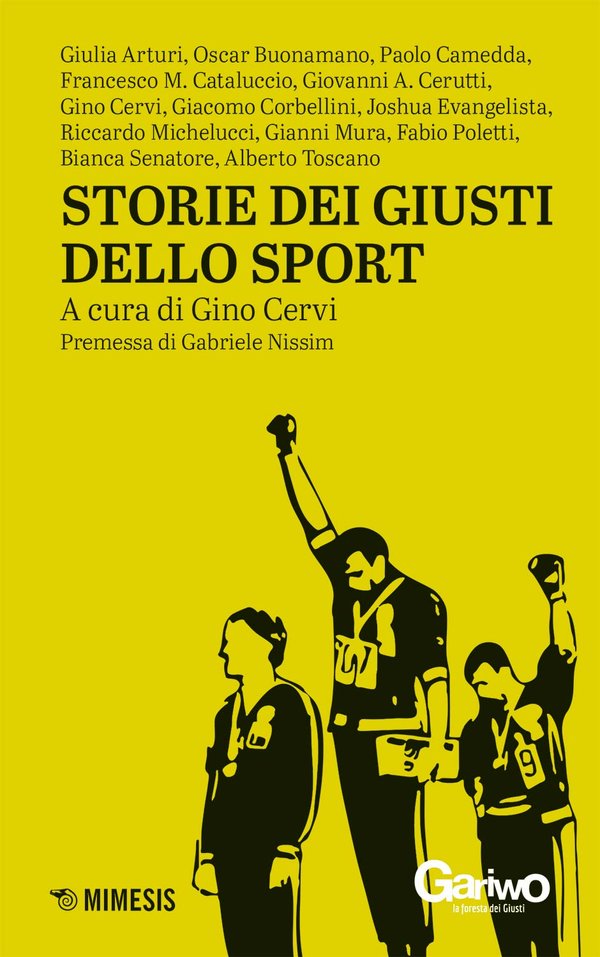
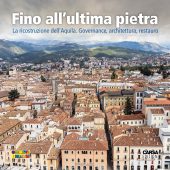
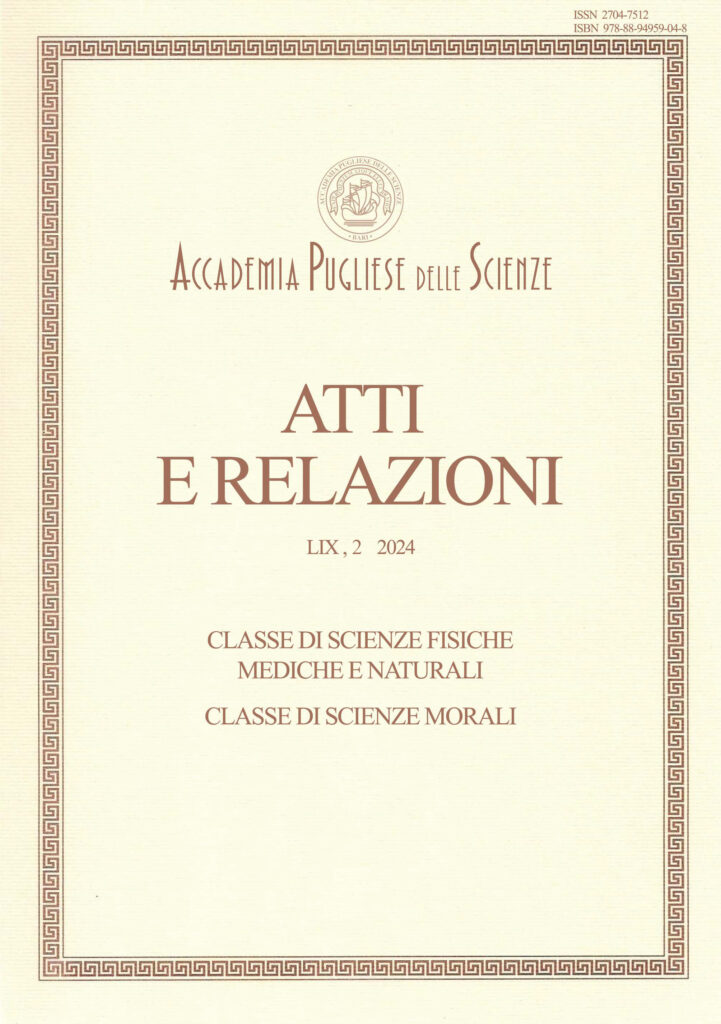

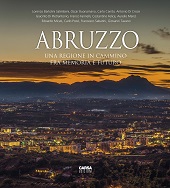
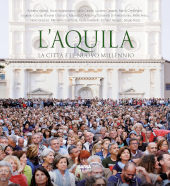
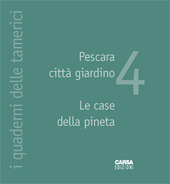



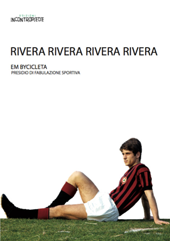
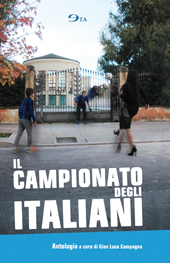
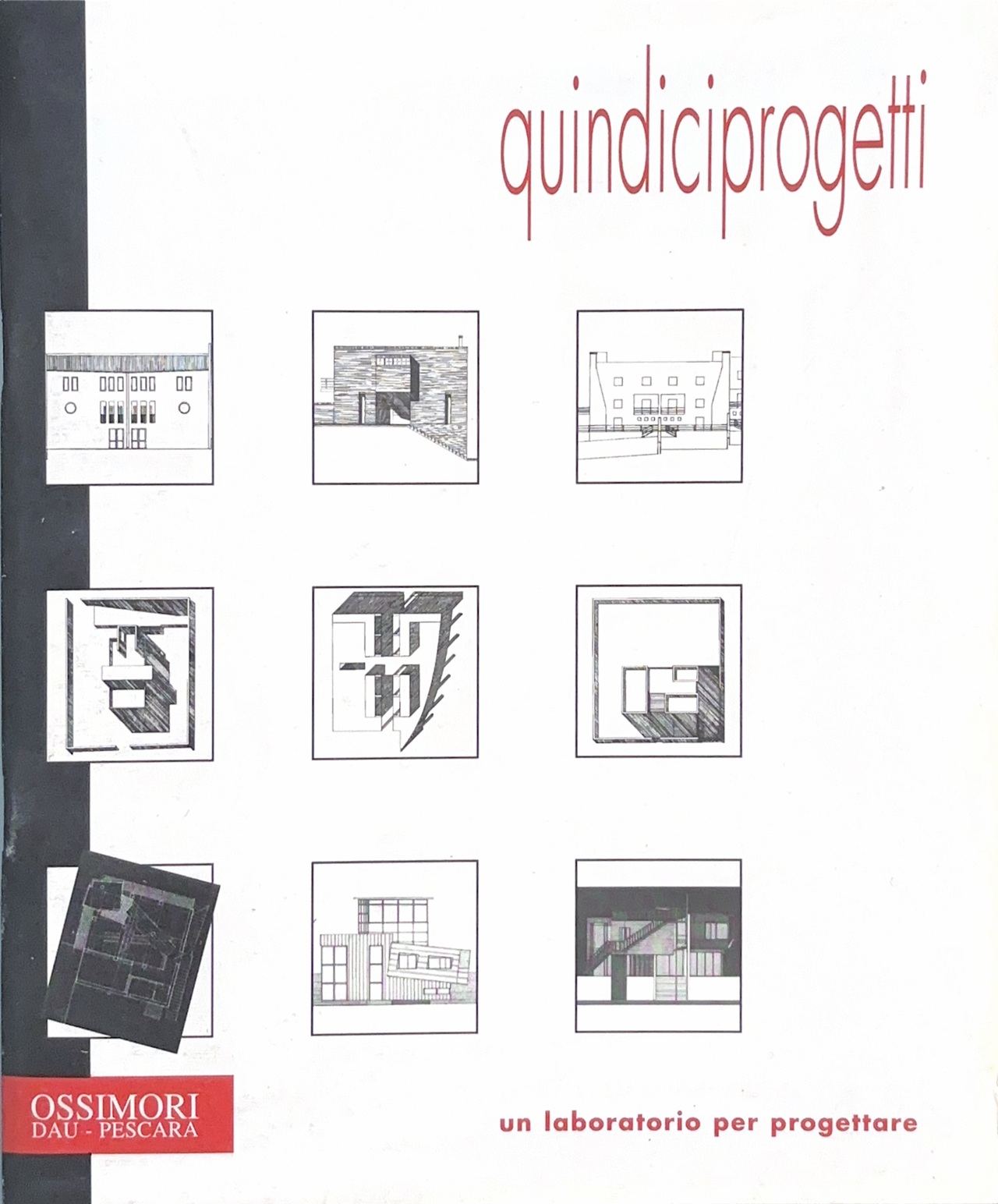
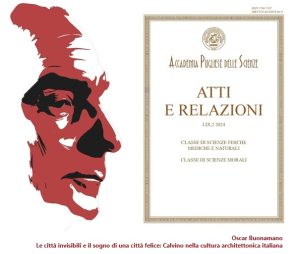
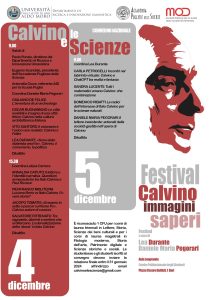
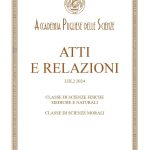



















Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.