NYC, 6 marzo 2009
Oggi le nostre strade si dividono. L’appuntamento è per le 17.00. St. Regis Hotel, 5th Avenue per uno dei due eventi culturali ai quali parteciperemo oggi, The Japanese Contemporary Art Show. Percorsi separati quindi, Lucia e Roberto per fiere e io alla ricerca delle nostre radici americane. Prendo la metropolitana, linea rossa n°1 giù fino al capolinea, South Ferry, e da lì il traghetto che mi porterà prima alla Statua della Libertà e poi, finalmente a Ellis Island.
Quando penso agli Stati uniti d’America, dall’Italia intendo, non ho mai una visione unica in mente. Penso sempre a tante cose. Tante cose tutte insieme che alcune volte si sovrappongono e altre si giustappongono. Questi due simboli dell’America mi fanno pensare invece sempre alla stessa cosa. A tutti gli italiani, e a tutti i meridionali in particolare, che sono arrivati qui come morti di fame e sono stati accolti. Spesso sono stati accolti male, ma sono stati accolti. E se l’America è oggi un grande Paese, una parte di merito va riconosciuta a tutti i morti di fame del mondo che sono arrivati carichi di speranze e senza un soldo sulle banchine di Ellis Island. Quando dagli oblò delle navi scorgevano la fiaccola e la corona che cinge il capo della statua capivano di essere arrivati nella terra promessa. E chissà quali pensieri frullavano nelle loro teste quando mettevano piede sul territorio americano tanto sognato. E le aspettative e i sogni erano sicuramente le cose più preziose che possedevano e portavano con loro.
Ho sempre immaginato che la mia prima volta negli Stati Uniti d’America coincidesse con una visita doverosa a questi luoghi.
E adesso ci sono.
La strada che separa la fermata della metropolitana dal molo è breve. Per arrivarci si attraversa un piccolo parco le cui strade interne sono disegnate da lunghe panchine in legno e attraversate da scoiattoli. Anche stamattina fa abbastanza freddo, c’è poco sole ma una bella luce che asseconda il pensare e invoglia a scrivere. Anzi è il tempo ideale per scrivere. Almeno per me.
Questo attraversamento mi fa pensare di nuovo che New York City è un’immagine fissa nella nostra mente, l’abbiamo già vista. Tutti. L’ho sicuramente vista in Trilogia di New York di Paul Auster. Questi edifici sono gli stessi di cui ho letto tante e tante volte, come gli stessi sono queste strade e questi taxi. Tutto è uguale a come lo immaginavo eppure tutto è nuovo e m’emoziona. Guardo dalla coda del battello la città che si allontana e la statua che s’avvicina. E c’è un silenzio e una pace che rassicura e cura. Frammenti di bellezza per ascoltare, in pace, il silenzio.
Quando scendiamo sull’isola il freddo è aumentato così come il silenzio. Il battello si svuota in poco tempo e subito riparte, carico di turisti del turno precedente, per Ellis Island. Resto per più di un’ora sull’isola. Non entro per ammirare il panorama, preferisco guardare la statua e la città all’aria aperta. Questo freddo mi piace. Tiene vivi. Sono in perfetta armonia con me stesso. Sono a New York e a dispetto di tutti i luoghi comuni non c’è confusione e caos, ma silenzio e poi ancora silenzio e pace.
Mi avvio verso il piccolo molo per aspettare il battello che mi porterà a Ellis Island. Il momento tanto atteso sta per arrivare e io mi sento pronto.
Una grande copertura in vetro t’introduce nella hall dell’Immigration Museum di Ellis Island. Oltre 12 milioni di immigrati sono passati per questa sala, tra il 1892 e il 1954, anno in cui la struttura chiuse i battenti. Arrivavano da tutto il mondo, Inghilterra, Germania, Irlanda e ovviamente dall’Italia. Venivano sottoposti a una visita medica e dopo aver effettuato alcuni controlli anagrafici la maggior parte di loro aveva l’autorizzazione per entrare negli Stati uniti d’America, soprattutto per quelli che viaggiavano in nave e transitavano in prima e seconda classe. Per quelli della terza classe le procedure erano più complicate e in ogni caso si completavano nel corso di una giornata. Nei giorni di maggior afflusso gli emigranti potevano superare le 10.000 unità. Se penso ai nostri CPT, centri di permanenza temporanea, le strutture per ospitare i migranti che giungono in Italia, e a quello che è successo solo pochi giorni fa a Lampedusa quando una di queste strutture è andata in fiamme, diventa plasticamente visibile la differenza tra un grande Paese e un Paese di cialtroni. Tra un Paese che ha fatto dell’accoglienza la sua forza e la sua ricchezza e un Paese di emigranti che rinnega la sua storia più recente per rinchiudersi in recinti identitari il cui unico valore sembra essere l’egoismo e la paura del diverso da sé.
Quelli che non erano proprio alla canna del gas e avevano qualche soldo potevano rivolgersi all’ufficio cambi e con i primi dollari americani in mano potevano mangiare qualcosa al bar di Ellis Island. Per gli altri, che erano la maggior parte, iniziava una nuova avventura in cui il primo obiettivo era procurarsi cibo e un posto dove dormire.
Il museo allestito a Ellis Island è in realtà un centro di documentazione mondiale sull’emigrazione. E quando arrivi alla fine del percorso espositivo, e prima di entrare nell’immancabile book shop, una sala con diverse postazioni dotate di computer ti dà la possibilità di accedere a un ampio database per effettuare, ricerche, previa registrazione. Le grandi fotografie in bianco e nero e i tanti oggetti posti lungo il percorso che si sviluppa su due livelli ti fa entrare in una dimensione altra. Ti senti parte di quella fauna umana che, disposta in lunghe e ordinate file, aspetta silenziosa il proprio turno. E se ti lasci trasportare dalle emozioni temi di non superare la visita medica e di essere rispedito indietro. Di notevole impatto emotivo due filmati che vengono proiettati più volte al giorno.
Guardo l’orologio, 15.30, mi sono perso a Ellis Island.
Non mangio nulla e mi dirigo all’imbarco. In meno di un’ora sarò al St. Regis Hotel, all’appuntamento con Lucia e Roberto. Il cambio di registro è notevole. Passo dalle storie di uomini e donne disperati che dal primo Novecento fino a tutto il periodo post bellico s’imbarcano su improbabili navi per aggrapparsi alla vita, all’arte contemporanea giapponese. Ma siamo a New York e qui tante cose possono convivere.
La mostra è in una delle suite del St. Regis Hotel. Quando arrivo Lucia e Roberto sono già lì che mi aspettano per salire. Non c’è molta gente. Una ragazza molto carina ci fa accomodare e ci invita a firmare il libro degli ospiti. Le mostre d’arte contemporanea negli alberghi se le sono inventate gli americani e a ruota sono stati imitati un po’ da tutti. Puoi approfittare per guardare dei quadri o delle installazioni e nello stesso tempo goderti la suite dell’albergo.
La mostra invade tutti gli spazi del piccolo appartamento. Nella zona giorno si proietta un video proprio sopra il camino. Nelle due camere da letto quadri ovunque così come nel bagno e nell’antibagno. Ho fame e qui offrono frutta e acqua. Mentre mangio frutta mi accorgo che Roberto ha conosciuto l’artista giapponese che espone. È un ragazzo molto giovane, il suo nome è Yuki Itoda. Noto che si scambiano i biglietti da visita e mi par di capire che si danno appuntamento per l’evento che ci sarà domani sera. “The Boiler” a Williamsburg, il nuovo quartiere degli artisti a Brooklyn.
Torniamo a casa. Una breve sosta e ripartiamo. Ci attende la performance di Vanessa Beecroft al Deitch Studios a Long Island City. Verrà con noi Maryann e ci andremo con la sua macchina. Arriviamo in ritardo perché ci fermiamo in Union Square a mangiare un panino. Anzi “il” panino. Il panino “must” per i newyorkesi. Bagel, un panino rotondo aromatizzato, con salmone e formaggio fresco; Novie il nome, 6,50 dollari il prezzo.
È difficile arrivare al Deitch Studios e la macchina di Maryann non ha il navigatore satellitare. Lo spettacolo che il water front offre di notte è di quelli che spezzano il fiato. È talmente bello che sembra finto. Una serata particolare, molto particolare. La performance di Vanessa Beecroft è l’evento più cool della fiera, o meglio l’evento più cool a cui io partecipo.
Torniamo a casa. Una breve sosta e ripartiamo. Ci attende la performance di Vanessa Beecroft al Deitch Studios a Long Island City. Verrà con noi Maryann e ci andremo con la sua macchina. Arriviamo in ritardo perché ci fermiamo in Union Square a mangiare un panino. Anzi “il” panino. Il panino “must” per i newyorkesi. Bagel, un panino rotondo aromatizzato, con salmone e formaggio fresco; Novie il nome, 6,50 dollari il prezzo.
È difficile arrivare al Deitch Studios e la macchina di Maryann non ha il navigatore satellitare. Lo spettacolo che il water front offre di notte è di quelli che spezzano il fiato. È talmente bello che sembra finto. Una serata particolare, molto particolare. La performance di Vanessa Beecroft è l’evento più cool della fiera, o meglio l’evento più cool a cui io partecipo.
Un contrappunto tra la vita che sta per andare via e la morte che sta per arrivare. Con quel bianco che rende le donne uguali ai calchi, inanimate. E poi d’improvviso impercettibili movimenti e piccoli spazi non invasi dal bianco che rendono quei corpi e quelle donne vive. Qui, al centro del mondo, il bianco e la vita e poi la morte, forse.
Beviamo una birra e non mangiamo nulla. È quasi mezzanotte e Plum in West 14th Street non è distante. C’é una festa, una delle tante feste di questa settimana d’arte a NYC.
Ci arriviamo in poco tempo, cinque, dieci minuti. Da fuori non sembra un bel posto. Entriamo. La musica è a un volume altissimo. Non c’è molta gente. Ci guardiamo intorno. Una, due, tre volte. Senza dirci nulla ci ritroviamo tutti e quattro fuori dal locale. Anche questa lunga, lunghissima, giornata sta per terminare.

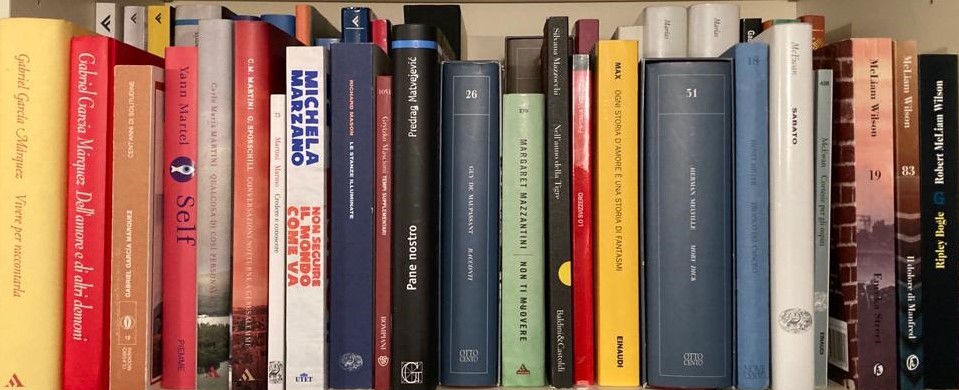
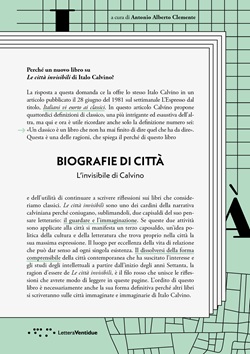
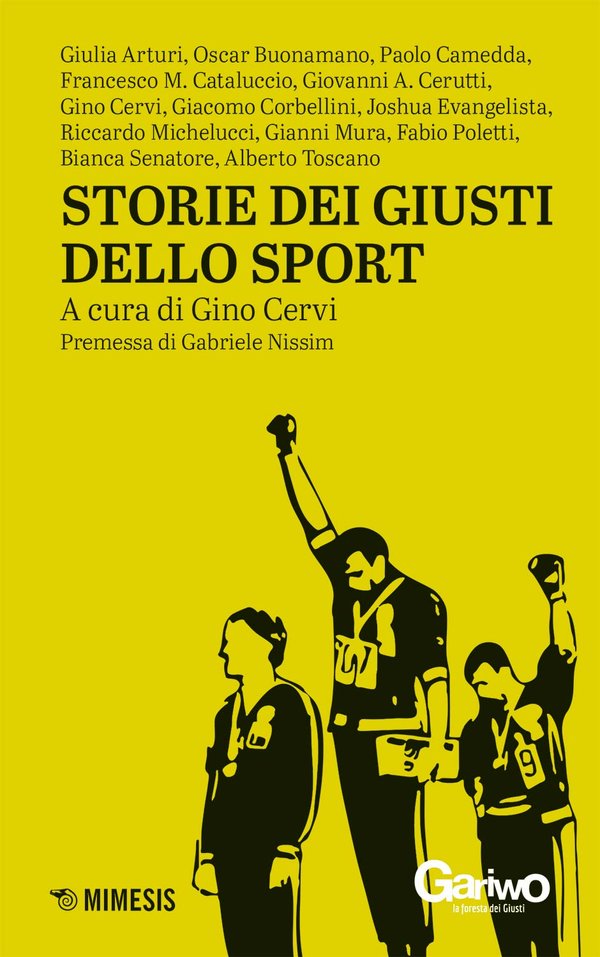
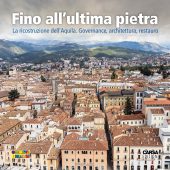
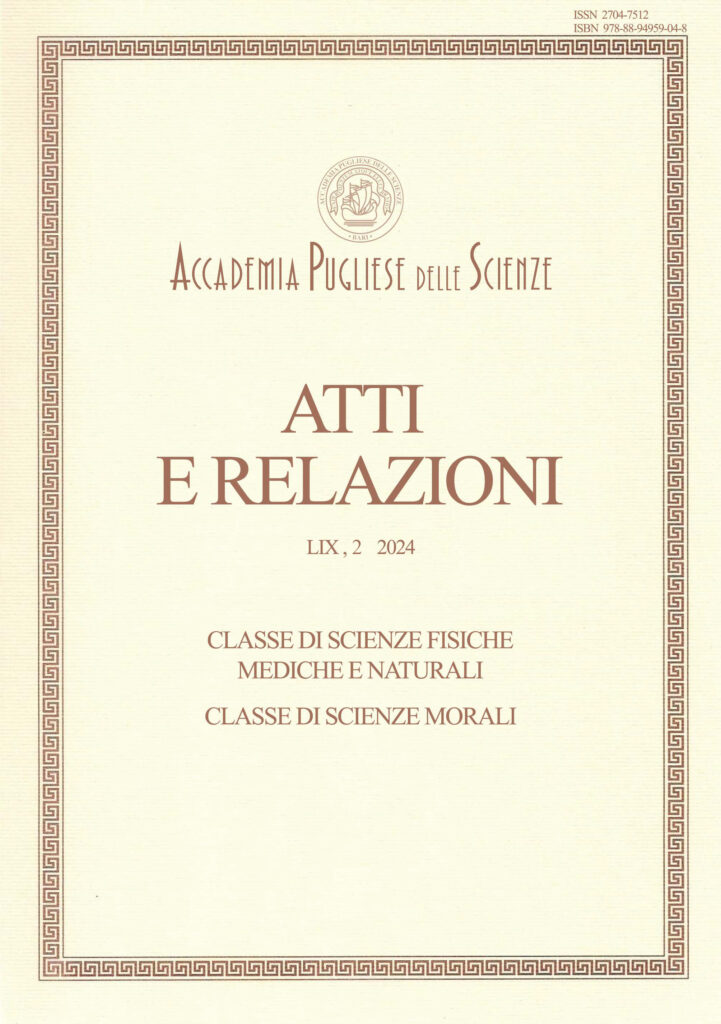

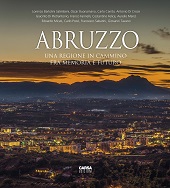
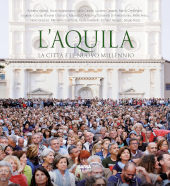
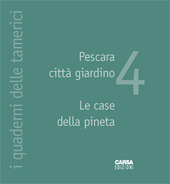



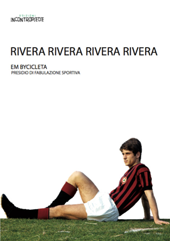
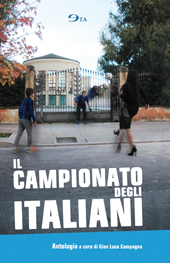
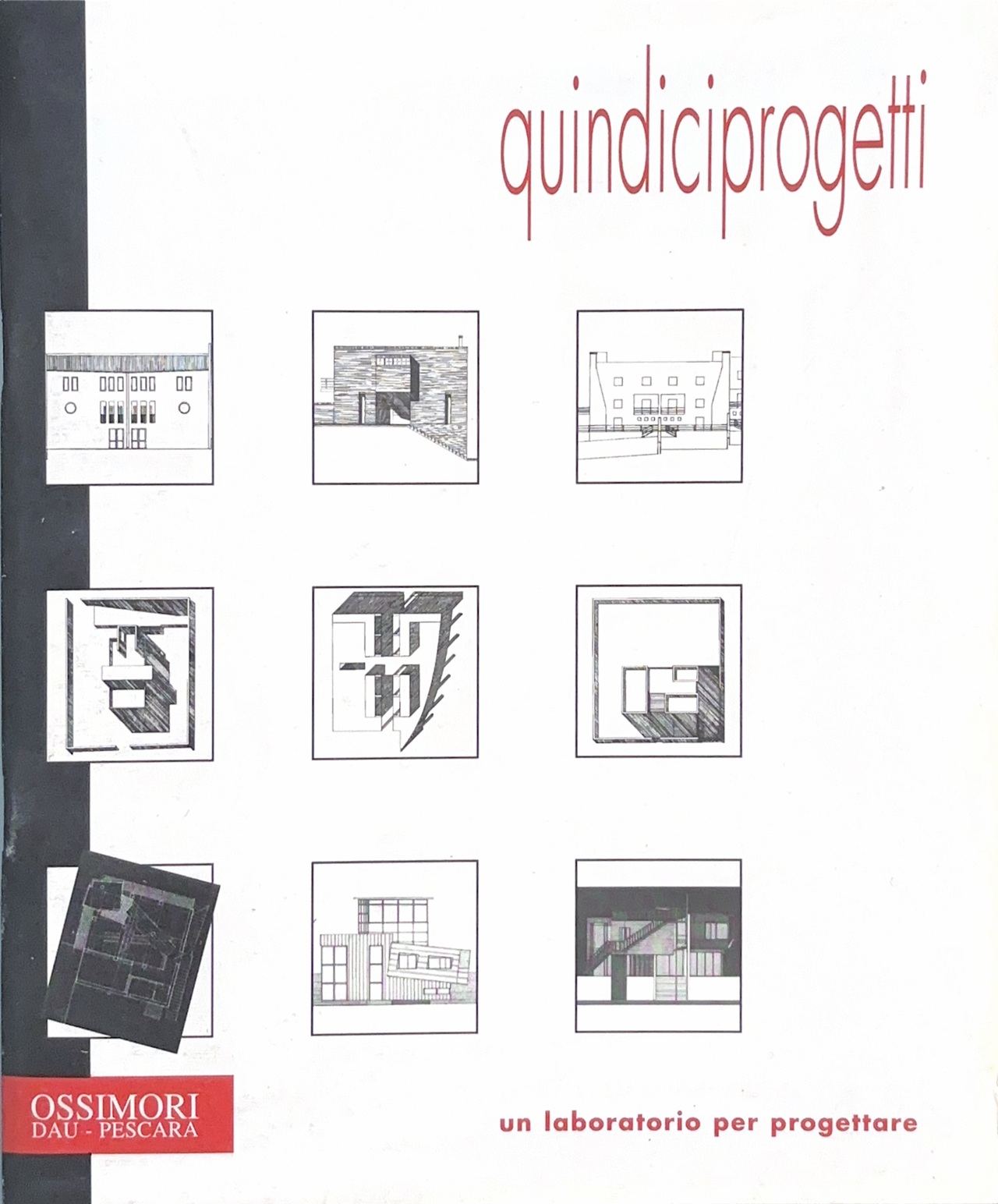

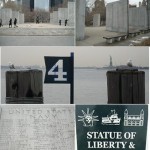















Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.