 L’alluvione di Genova, di questi ultimi giorni dell’anno, testimonia che in Italia il livello di guardia è stato ampiamente superato non solo nella vita sociale e civile. E le parole pronunciate da Claudio Magris, ospite in tv da Fabio Fazio, diventano anche per questo motivo una sintesi possibile ed estrema di questo suo lavoro: «Sono saltate le elementari regole di comportamento, è andata in crisi una virtù fondamentale: il rispetto». Il rispetto delle regole innanzitutto.Ma andiamo con ordine. Livelli di guardia (Garzanti, 208 pp, € 18,00) è l’ultimo libro di Claudio Magris, una raccolta di articoli pubblicati a partire dal 22 giugno 2006 e fino al 9 settembre 2011. Non seguono un ordine tematico ma cronologico «sono tutti nati a caldo in risposta e per reazione a eventi, vicende o polemiche che hanno segnato – sanguinosamente, indecentemente, comicamente, contraddittoriamente, a seconda dei casi – la vita civile italiana di questi anni». Pensieri, note, riflessioni, che pur scaturendo da fatti di cronaca o contingenti mostrano di reggere il confronto con il tempo che passa e hanno un valore universale che va aldilà e oltre il tempo in cui sono state concepite. Ognuno di questi brevi saggi insegna sempre qualcosa di nuovo che supera l’argomento da cui prende il via. Citazioni, rimandi, affinità che emergono e si staccano dalla pagina per trasformare brevi commenti in piccoli capolavori di filosofia, storia, morale. In queste pagine ci sono i capisaldi della cultura classica, i grandi autori della letteratura, i pensatori. Gli uomini che hanno costruito parola dopo parola, pensiero dopo pensiero, l’immaginario collettivo con il quale ci confrontiamo e guardiamo il mondo. «Note civili», come recita il sottotitolo, merce ormai rara, rarissima, nella società del consumo fine a se stesso che abitiamo. Tanti gli argomenti indagati, molti dei quali riguardano direttamente la vita nel nostro Paese, la nostra stessa convivenza civile.
L’alluvione di Genova, di questi ultimi giorni dell’anno, testimonia che in Italia il livello di guardia è stato ampiamente superato non solo nella vita sociale e civile. E le parole pronunciate da Claudio Magris, ospite in tv da Fabio Fazio, diventano anche per questo motivo una sintesi possibile ed estrema di questo suo lavoro: «Sono saltate le elementari regole di comportamento, è andata in crisi una virtù fondamentale: il rispetto». Il rispetto delle regole innanzitutto.Ma andiamo con ordine. Livelli di guardia (Garzanti, 208 pp, € 18,00) è l’ultimo libro di Claudio Magris, una raccolta di articoli pubblicati a partire dal 22 giugno 2006 e fino al 9 settembre 2011. Non seguono un ordine tematico ma cronologico «sono tutti nati a caldo in risposta e per reazione a eventi, vicende o polemiche che hanno segnato – sanguinosamente, indecentemente, comicamente, contraddittoriamente, a seconda dei casi – la vita civile italiana di questi anni». Pensieri, note, riflessioni, che pur scaturendo da fatti di cronaca o contingenti mostrano di reggere il confronto con il tempo che passa e hanno un valore universale che va aldilà e oltre il tempo in cui sono state concepite. Ognuno di questi brevi saggi insegna sempre qualcosa di nuovo che supera l’argomento da cui prende il via. Citazioni, rimandi, affinità che emergono e si staccano dalla pagina per trasformare brevi commenti in piccoli capolavori di filosofia, storia, morale. In queste pagine ci sono i capisaldi della cultura classica, i grandi autori della letteratura, i pensatori. Gli uomini che hanno costruito parola dopo parola, pensiero dopo pensiero, l’immaginario collettivo con il quale ci confrontiamo e guardiamo il mondo. «Note civili», come recita il sottotitolo, merce ormai rara, rarissima, nella società del consumo fine a se stesso che abitiamo. Tanti gli argomenti indagati, molti dei quali riguardano direttamente la vita nel nostro Paese, la nostra stessa convivenza civile.
«Qualche anno fa, Jürgen Habermas, il filosofo forse oggi più autorevole in Germania, aveva proclamato il “Verfassungspatriotismus”, il patriottismo della Costituzione, quale punto dio riferimento, quasi collante, per l’identità tedesca; quale valore in cui i cittadini del suo Paese potevano riconoscersi e trovare una loro unità, il senso di una comune appartenenza e di un comune destino, di una Patria […] Il nuovo patriottismo formulato da Habermas andava e va tuttavia aldilà dello specifico trauma tedesco ed è destinato a diventare sempre più valido nei Paesi e nei contesti più diversi».
Come non pensare allora agli attacchi scriteriati e senza prospettiva che in questi ultimi anni forze politiche «estranee al travaglio che ha generato la nostra storia conflittuale ma comune» hanno sferrato, senza riuscirci per nostra fortuna, alla Carta Costituzionale? Parole che richiamano alla mente altre parole, quelle usate dal giudice Antonio Ingroia, «sono un partigiano della Costituzione» e la canea dei politici e dei commentatori incapaci di ascoltare perché distratti dal loro stesso abbaiare. Saper guardare oltre il proprio piccolo recinto, in questo caso Magris attinge alla cultura tedesca di cui è uno dei più apprezzati studiosi, contribuisce alla ricerca di un’idea condivisa e universale di alcuni valori fondanti della società. Così com’è per i temi eticamente sensibili. Il valore e il senso della vita e della morte innanzitutto.
«La vita è certo un valore, ma non è detto che sia il valore supremo; gli antichi ammonivano a non perdere, per amore della vita, per sopravvivere a ogni costo, le sue ragioni e il suo significato (propter vitam vivendi perdere causas); vivere torturando forse non è vivere. Chi vuol salvare la propria vita la perderà e chi è disposto a perderla la salverà, sta scritto nel Vangelo, testo non certo incline alle trombonate». Magris affronta qui il tema del valore della vita, in questo primo caso il tema di fondo è la guerra e le aberrazioni che questa porta con sé. Di chi muore per salvare la vita degli altri. «Molti soldati americani sono morti per liberare l’Europa, ma dubito che la loro morte tolga valore ai princìpi che li hanno mandati a morire». Affronta poi in rapida sequenza un tema che ciclicamente, e in assenza di una legge ad hoc, divide l’opinione pubblica italiana, l’eutanasia.
«Oltre un certo limite, quando la condizione umana viene radicalmente sfigurata o il dolore diventa insostenibile, ogni comandamento o divieto, ogni imperativo morale categorico, ogni articolo di codice appaiono grottescamente inadeguati a quell’intollerabile strazio, assurdi, quasi caricature di sé stessi […] Togliere – letteralmente o metaforicamente – staccare la spina può essere comunque un gesto amoroso e coraggioso solo se lo si fa pensando al bene dell’altro e non, magari inconsciamente, alle proprie sofferenze per il suo stato, che la morte infine placa. Bernanos parlava di certe anime così sensibili da no poter sopportare la vista di una bestiola che soffre sicché finiscono per schiacciarla col piede».
Non si esime dall’intervenire su un tema molto contiguo all’eutanasia e di stringente attualità e che riguarda il dolore e il peso di un’esistenza quando questa diventa insostenibile.
«Grandi civiltà come quella classica non hanno avuto paura della morte né del suicidio, che – non necessariamente solo in circostanze disperate, ma per vari motivi – la anticipa, comunque di poco. È una grande perdita che si sia perduta questa naturalezza della morte. Non è la vita a essere sacra; la vita è mera opinione, diceva Marco Aurelio, ed è arduo dire, dinanzi alle piramidi di sofferenze accumulate in milioni di anni, che essa sia un bene e che il big bang sia un anniversario da festeggiare».
Nel libro non è mai citato Silvio Berlusconi che con i suoi comportamenti, pubblici e privati, è però certamente uno dei grandi protagonisti di queste riflessioni. In questo senso illuminante è il capitolo “La rara arte di uscire di scena”. Qui Magris fa ricorso al padre della lingua italiana per esprimere al meglio il suo pensiero: «Il monito dantesco a saper “calar le vele e raccoglier le sarte” è assai poco ascoltato, particolarmente nel mondo della politica italiana, nel quale nessuno esce di scena, se non quando vi è proprio costretto a forza dalla comare secca».
In appendice a “Livelli di guardia” c’è il discorso che ha tenuto in occasione del conferimento del Friedensreis des Deutschen Buchandels, nella Paulskirche di Francoforte. Un discorso che in parte riassume molti dei temi di cui scrive nel libro. «Dell’universalità della guerra» e di come crediamo che essa sia inevitabile.
Volevo esprimere due pensieri che sono anche risvolti di una stessa medaglia e che mi stanno molto a cuore. Da un lato l’illusione che le guerre siano state già tutte superate. Un eccesso d’ingenuità perché sottovalutando un pericolo lo si rende ancora più forte. Basta pensare alle guerre balcaniche.
Non dimentico il discorso di un anziano leader nord-vietnamita che diceva «il pericolo per noi più insidioso è l’abitudine a considerare la guerra necessaria come la vita». In questo senso siamo tutti ciechi conservatori, abbiamo difficoltà a credere che le cose cambino. Anche quando è caduto il Muro di Berlino gli stessi tedeschi che lo stavano abbattendo non pensavano che tutto potesse finire in poco tempo. Due o tre giorni dopo il Muro non c’era più.
Lei vede l’Europa come una possibile ancora di salvezza a patto che l’Europa si apra alle nuove culture dei nuovi europei.
Sono un patriota europeo nel senso che il mio sogno è un’Europa che sia un vero Stato federale. Per una ragione molto pratica, i problemi che abbiamo davanti a noi sono europei. Pensi all’immigrazione, è ridicolo avere leggi diverse in Europa così com’è ridicolo avere leggi diverse a Firenze o a Trieste. Una catastrofe che colpisce Milano investe anche Trieste. A una realtà di fatto deve corrispondere anche una realtà formale. Basta con la febbre identitaria delle piccole patrie perché è soltanto una caricatura. Viviamo un momento di estrema debolezza dell’Europa, bisogna essere pessimisti con la ragione, come diceva Gramsci, ma ottimisti con la volontà.
Il valore della vita e il senso della stesso della vita pervadono il suo ultimo lavoro. Non poteva non affrontare il tema della Shoà, perché «la Shoà è nel nostro DNA»
La Shoà è stato un fenomeno mostruoso e simbolo di un male assoluto. Bisogna capirne le ragioni storiche e sociali senza perder di vista il suo terribile primato nella sofferenza. La Shoà però non è l’unica barbarie della storia e non può farci dimenticare le altre angherie, il tremendo primato nella sofferenza non significa e non può significare monopolio della sofferenza.
Ha ottenuto tanti importanti riconoscimenti per il suo lavoro. Negli ultimi anni il suo nome è sempre tra i possibili vincitori del Nobel per la letteratura. Come vive questa condizione?
Non esistono candidati al premio Nobel, i nomi di cui si scrive e si parla sono semplicemente i nomi che i broker londinesi esibiscono per implementare il mondo delle scommesse ed è escluso nel modo più assoluto che tali nomi possano essere il risultato di indiscrezioni. L’Accademia svedese può giudicare bene o male ma escludo che facciano circolare nomi di presunti candidati. Queste notizie non hanno alcun fondamento. Riguarda me ma anche gli altri. In ogni caso qualunque riconoscimento lo si accetta sempre con piacere. Sono sempre dei doni.
Qual è il suo rapporto con l’Abruzzo?
Nel 1955 ho percorso a piedi l’Abruzzo con un mio amico che aveva delle prozie ad Ancarano, il professor Giovanni Gabrielli che incontro proprio stasera a Trieste per bere una birra in amicizia. Prima la “Montagna dei Fiori” dove abbiamo anche dormito con i pastori. Quando attraversavamo i piccoli paesi dell’entroterra gli abitanti c’invitavano spesso a pranzo o a cena. Mi ricordo che in un piccolissimo paese la gente si chiedeva spesso chi fossimo, e non di rado la risposta che proveniva dai più informati era sempre la stessa: sono tedeschi dell’Alta Italia. Gran belle passeggiate. Il Gran Sasso, Campo Imperatore, Assergi per finire la corsa a L’Aquila. L’anno successivo, nel 1956, la comitiva diventò più grande e il gruppo diventò di quattro persone. L’obiettivo da raggiungere la Majella. Ricevemmo un’ospitalità meravigliosa dappertutto e in particolare a Guardiagrele. Sempre quell’anno a Lama dei Peligni ci spacciammo per speleologici triestini di una fantomatica e inesistente rivista “Specus”. Ho dei bellissimi ricordi legati all’Abruzzo.

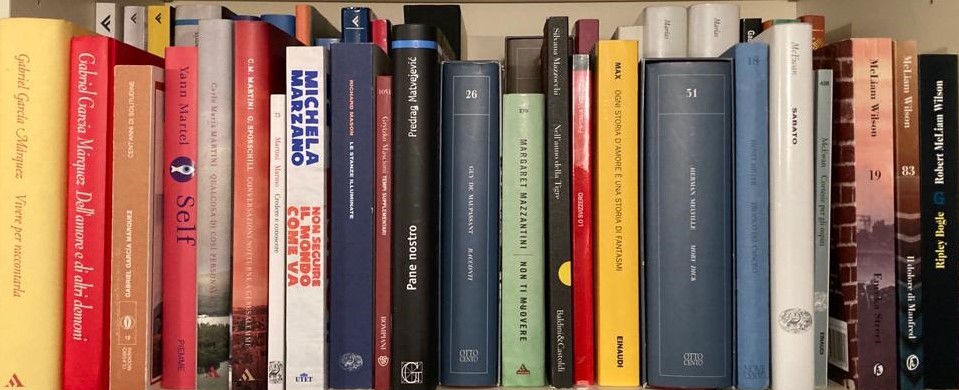
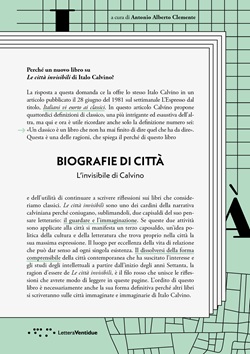
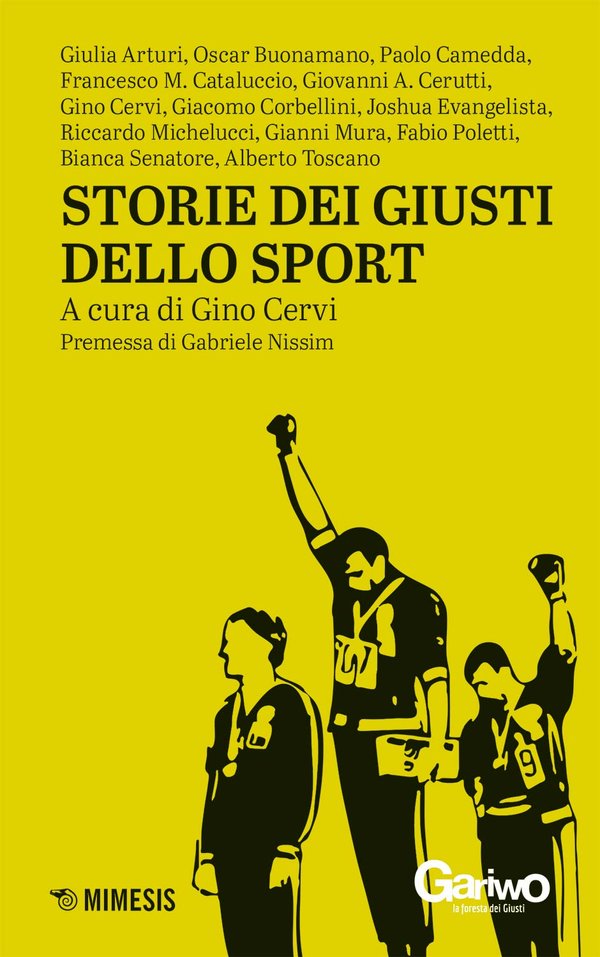
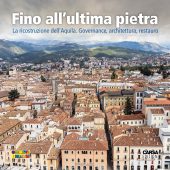
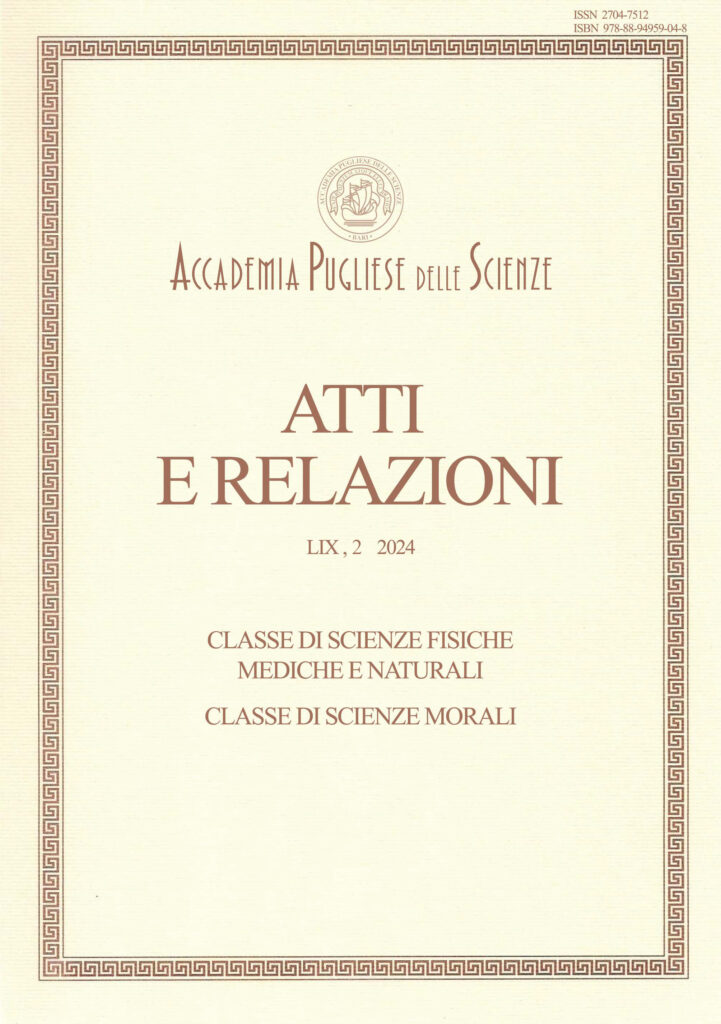

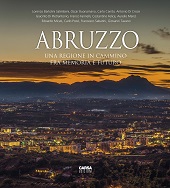
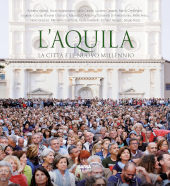
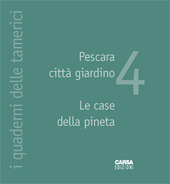



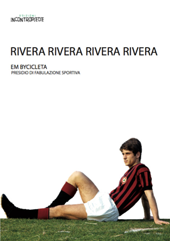
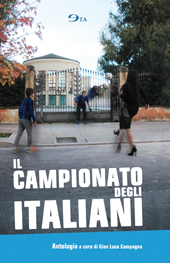
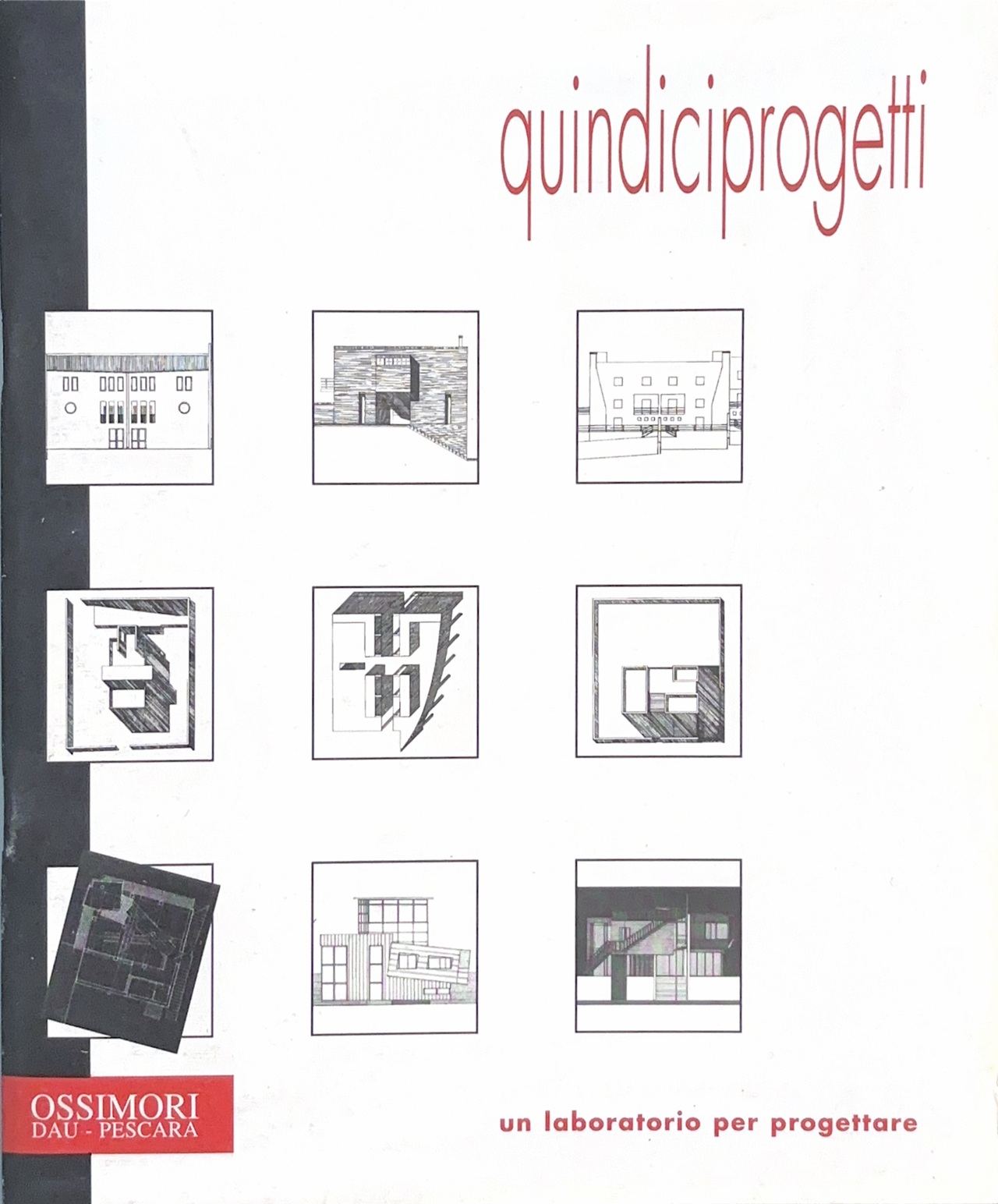





Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.