 Sono andato via dalla mia città quando avevo diciotto anni, perché non l’ho mai sentita “la mia città”.
Sono andato via dalla mia città quando avevo diciotto anni, perché non l’ho mai sentita “la mia città”.
Il servizio militare prima e l’università poi, hanno assecondato una scelta che in cuor mio avevo fatto da tempo. E questa scelta nasceva dalla sensazione di sentirmi in un luogo popolato, vissuto, consumato, da persone che sentivo estranee. Mi sono sempre visto ed immaginato altrove.
Ho sempre pensato la mia vita in un luogo altro, forse un luogo qualunque, sicuramente non quello in cui ero nato.
Con il passare degli anni ripenso spesso a questa scelta e ogni volta cerco di capirne le ragioni più profonde. All’inizio non m’interrogavo su questo, cercavo di non pensarci. Le radici, la famiglia, la scuola, le prime storie d’amore e tante, troppe cose abbandonate, non concluse, forse nemmeno iniziate. E ogni volta che ripenso alle ragioni dell’abbandono, queste cangiano, perché diversa, molto diversa è oggi quella città.
Sono diversi i volti delle persone e non solo perché sono cambiati con lo scorrere degli anni ma perché è cambiata la fisionomia. Le facce non sono più le stesse. È cambiata la composizione sociale della città e con essa le domande, i bisogni della gente che la abita, che la vive, che la consuma. Quando ci ritorno, molto raramente a dire la verità, mi capita di andare a casa di mio fratello e di non saper ritrovare la strada perché la città è cambiata molto anche nella struttura urbanistica. Nuovi quartieri, nuove centralità, nuovi non luoghi.
Quando c’ero io non c’era l’università. Non c’erano manifestazioni letterarie. Non c’era la “macchia gialla”. C’erano “i giardinhi” con tanti alberi e non fari portuali come fasci. Quando c’ero io non c’era il nuovo palazzo della Provincia. Non c’era l’aereo da combattimento corredato da un pupazzotto simile a una makumba.
Quando c’ero io c’era l’ippodromo, ma tutti lo chiamavano in altro modo. I “cavalli stalloni” era il suo nome. Io ci giocavo “a pallone”. Sfide interminabili che iniziavano nel primo pomeriggio per terminare quando era buio o quando, sfiniti, non riuscivamo più a correre e a segnare e a gioire. L’ultima partita che ho giocato “ai cavalli stalloni” me la ricordo bene. Era il giorno della festa del papà di non so più quale anno. La partita stava per terminare. Avevamo detto: chi segna questo gol vince tutto. Correvo sulla fascia destra, stanco, quasi stremato. Passo la palla ad Aurelio e mi dirigo verso il centro dell’area di rigore avversaria. Aurelio dribbla due avversari e crossa. Io arrivo in corsa e mentre sto per colpire la palla di testa sento un gran dolore alla bocca. Salvatore era entrato in rovesciata e mi aveva colpito in pieno viso. Colpisco la palla e segno il gol della vittoria e cado a terra semisvenuto. Poi non ricordo nulla. Mi sono svegliato al pronto soccorso con tre punti di sutura all’interno della bocca.
Oggi come scrive Michele Trecca in una articolo straordinario, La mia città (per una concezione urbanistica della letteratura), l’ippodromo, o i “cavalli stalloni” se preferite, è ancora lì, nelle stesse condizioni di tanti, ma proprio tanti anni fa. E continuando a leggere questa sua riflessione ho forse capito il perché del mio abbandono: la mia città non aveva un cuore. La città in cui sono nato e dove ho vissuto i primi diciotto anni della mia vita non aveva un cuore.
Per questo motivo leggere che «Nei libri che compra, la gente della mia città cerca quel cuore che le hanno strappato. Il cuore della mia città è un cuore grande quanto tutti i libri che la gente legge» in qualche misura mi aiuta a capire e a comprendere quella mia scelta e nello stesso mi conforta pensare che la città nella quale vivono i miei genitori, mia sorella, mio fratello e i miei nipoti, sia oggi popolata, vissuta, animata, da bella gente. Da Michele Trecca e tanti altri come lui.

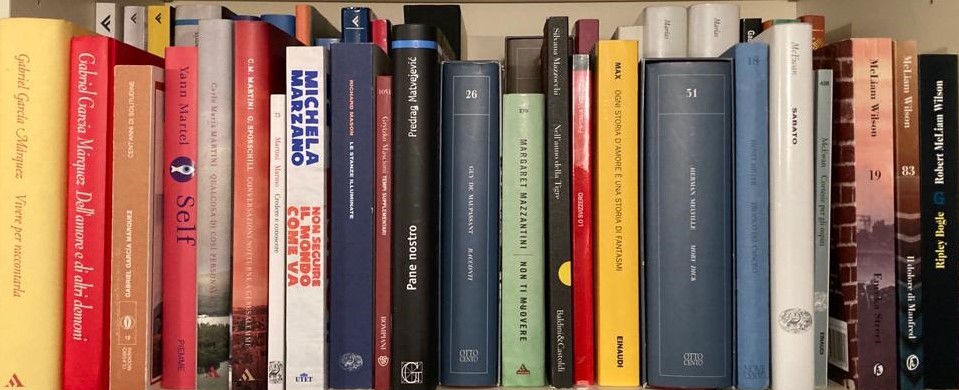



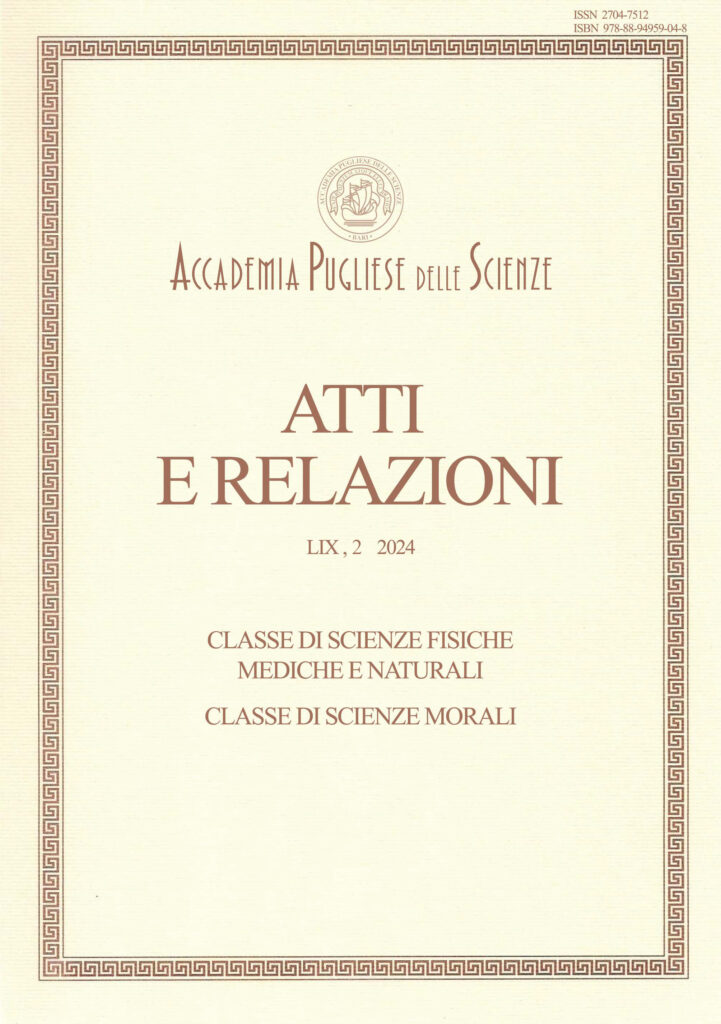

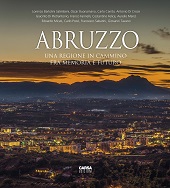





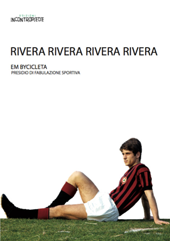

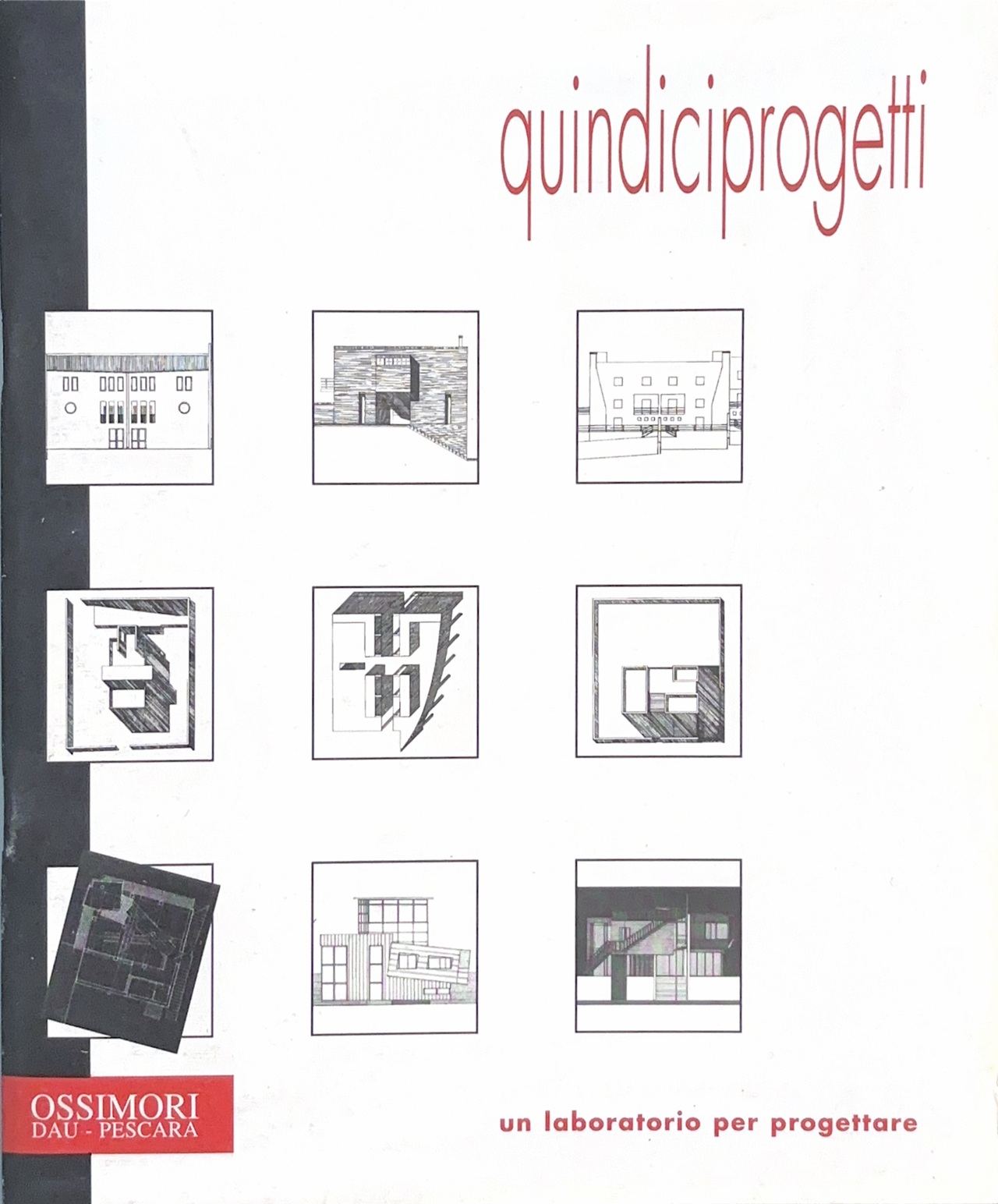





Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.