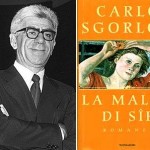 Pochi giorni fa, il giorno di Natale per essere più precisi, è morto lo scrittore Carlo Sgorlon. Ha raccontato il Friuli come mai prima nessuno era riuscito a fare. Ha scritto di uomini e di terra. Una bella persona che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa. Era l’estate del 1997 e Sgorlon era a Pescara per il Premio Flaiano. Lo incontrai in albergo, dopo la premiazione. Fu una bella conversazione che ricordo ancora oggi con grande piacere. L’intervista fu pubblicata su Sipario e oggi ve la ripropongo non solo per rendere un mio, piccolissimo, omaggio a Carlo Sgorlon, uomo e scrittore di gran vaglia, ma soprattutto perché è possibile leggere o ri-leggere, pensieri che aiutano a pensare.
Pochi giorni fa, il giorno di Natale per essere più precisi, è morto lo scrittore Carlo Sgorlon. Ha raccontato il Friuli come mai prima nessuno era riuscito a fare. Ha scritto di uomini e di terra. Una bella persona che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa. Era l’estate del 1997 e Sgorlon era a Pescara per il Premio Flaiano. Lo incontrai in albergo, dopo la premiazione. Fu una bella conversazione che ricordo ancora oggi con grande piacere. L’intervista fu pubblicata su Sipario e oggi ve la ripropongo non solo per rendere un mio, piccolissimo, omaggio a Carlo Sgorlon, uomo e scrittore di gran vaglia, ma soprattutto perché è possibile leggere o ri-leggere, pensieri che aiutano a pensare.
Per chi volesse approfondire la conoscenza di Sgorlon, www.sgorlon.it
Intervista a Carlo Sgorlon
vincitore del Superflaiano 97 con La Malga di Sîr edito dalla Mondadori
Carlo Sgorlon, friulano di Cassacco è il vincitore del Superflaiano ’97 per la letteratura. Con il suo ultimo romanzo, La Malga di Sîr, ha vinto la qualificata concorrenza di Dacia Margini e Patrick Robinson che gli contendevano il più prestigioso riconoscimento. Con 104 voti su 200 Sgorlon ha chiuso la partita in largo anticipo succedendo così ad Abraham B. Yehoshua che con un Un divorzio tardivo, edito da Einaudi, si era aggiudicato la passata edizione.
L’autore friulano, già vincitore di due Supercampiello, di un Premio Strega, di un Premio Napoli oltre che di altri numerosi riconoscimenti, fresco vincitore, da autore di razza qual è, durante e dopo la premiazione non ha fatto mancare le sue osservazioni sulla struttura del Premio Flaiano, individuando disfunzioni e indicando possibili correttivi. Non accetta però la definizione “polemica” per le sue dichiarazioni.
«Polemica viene dal greco “polemos” e vuol dire guerra. Io non faccio mai guerre a nessuno.» Tiene a sottolineare con grande serenità e voglia di raccontarsi. «Faccio semplicemente un osservazione. Mi pare che questo premio sia troppo vasto. E come sempre la vastità e nemica della concentrazione e non aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati. Una cosa tanto più è vasta meno riesce ad ottenere un effetto. Se fosse un premio soltanto di narrativa o solo di teatro o di cinema, probabilmente riuscirebbe ad ottenere attenzioni maggiori.»
Riuscirebbe a ottenere quello spazio che inutilmente ogni anno gli organizzatori reclamano.
C’è un’altra questione importante. Convocare tanta gente, distribuire tanti premi rappresenta una spesa enorme e questo sarebbe già un buon motivo per iniziare a diminuire i premi. Io naturalmente sono molto grato agli organizzatori e ai finanziatori perché mi è andata molto bene. Però un’osservazione che si può fare dall’esterno è certamente questa. Premiare tanta gente e un po’ come premiare nessuno. La stampa non da rilievo. Oggi una manifestazione per avere un effetto, una cassa di risonanza deve avere la stampa e la televisione alle spalle.
La vastità delle proposte forse nasce dalla poliedricità del personaggio a cui è intitolato il premio, Ennio Flaiano.
Flaiano si è occupato di teatro, di cinema, di narrativa, ha scritto racconti, aforismi. Può essere che la molteplicità degli aspetti di questo premio in qualche maniera si ispiri veramente a Flaiano. Rimane però l’osservazione iniziale che è un premio troppo vasto. A questo proposito si potrebbero usare le parole di Dostojevski: la psicologia dell’uomo è troppa vasta, io la restringerei.
Lei si è aggiudicato il Superflaiano ’97 per la letteratura pensa che nei prossimi anni la letteratura assumerà un ruolo più centrale nella società o sarà costretta sempre e comunque in ambiti più riservati?
È una questione molto vasta. Per me la letteratura è un fatto eterno. Più di letteratura però parlerei di poesia o di un sentimento della vita che gli uomini continueranno ad avere. Guardando alla società si ha l’impressione che il livello di cultura della gente progressivamente si sia abbassato e che un po’ tutti sembrano più interessati verso cose futili e superficiali. Resiste però sempre un nucleo forte di lettori, di scrittori, uno zoccolo duro. Per fortuna duro. Credo che continuerà ad esserci un nucleo di persone che penserà ai problemi eterni dell’uomo, ai sentimenti universali, che si dedicherà sempre alla letteratura passivamente o attivamente. Leggendo o scrivendo.
Ma quale sarà il ruolo della letteratura?
Rispetto a questo sono abbastanza severo. Non che io pensi allo scrittore quale si pensava nel dopoguerra, all’epoca di Sartre. Però credo che uno scrittore, per essere considerato tale, debba impegnare tutto se stesso, tutta la sua umanità e anche tutta la sua etica. Oggi, purtroppo, le poetiche moderne hanno separato l’etica dalla letteratura, io non le separerei. Le rimetterei vicino come aveva fatto il De Santis. Quando uno scrive deve metterci tutta la sua etica, altrimenti mette un’etica rovesciata, come per esempio il marchese De Sade, che una volta era considerato un povero matto e oggi è considerato un grande scrittore e pubblicato da Gallimard in Francia.
Lei che tipo di scrittore si ritiene?
Io mi ritengo uno scrittore impegnato. Non politicamente perché non ho interessi particolari, di una parte, da difendere. Sono impegnato dal punto di vista etico. La mia etica, il mio modo di sentire il mondo, i miei sentimenti autentici, li metto nella letteratura e questo la gente lo sente. Quando partecipo a concorsi in cui ci sono giurie popolari vinco sempre. Ho vinto decine di premi importanti così. Ma non di quella gente che è responsabile di una trasformazione in senso sofistico e artificioso della cultura. Perché noi oggi viviamo all’interno di una cultura che non è più naturale, che non ha più il senso comune, che non ha più il senso delle cose genuine, delle cose autentiche, perché l’ha perduto. Si è allontanata dalla natura, dall’essere, si è allontanata dai sentimenti fondamentali, archetipi dell’uomo e naviga nell’assurdo. Perché non sa dove andare. Senza una meta, naviga alla cieca. La società di oggi mi pare che non abbia più un punto dove arrivare e l’unica cosa che ricerca è una libertà assoluta, totale, che si confonde con l’egoismo, il narcisismo, l’edonismo.
Con i suoi libri ha dato voce ad un popolo, quello friulano, che non era mai stato raccontato prima in maniera così esaustiva.
Io percepisco lo scrittore, almeno dal mio punto di vista di friulano, un po’ come un profeta. Profeta non nel senso che indovina l’avvenire che è l’interpretazione più insignificante, ma nel senso che parla a nome di una collettività, di un popolo. Quindi profeta in senso biblico.
I suoi libri colmano una lacuna.
Il popolo friulano, che è un popolo di contadini, di povera gente, di emigranti, non ha avuto periodi gloriosi nella letteratura, non ha avuto il periodo comunale, non ha avuto il periodo rinascimentale tantomeno quello umanistico. Io ho cerco di raccontare la storia di un popolo che nessuno ha scritto. E credo anche di esserci riuscito. Ho incontrato molta gente che mi ha detto di aver conosciuto il Friuli attraverso i miei libri.
Durante la premiazione lei ha detto che non esistono modi accattivanti di scrivere e che non c’è bisogno d’inventarsi nuovi meccanismi. La scrittura è sempre la stessa.
Deve esistere sempre l’invenzione dell’immaginazione ma non piuttosto l’invenzione di natura linguistica o di natura strutturale. Non che io rifiuti queste cose però devono essere molto spontanee e non costruite. Ci sono grandi innovatori della letteratura, due esempi su tutti, Kafka e Gadda. Nessuno dei due aveva la sensazione di essere un innovatore. Loro scrivevano così come gli veniva da dentro. Gadda aveva il gusto di lavorare con le parole, di mettere in scena parole di tutti i linguaggi, di tutti i dialetti, di tutte le lingue. Di elaborarli con quegli umori acidi perché lui era un tipo bizzarro. Ma non aveva la sensazione di essere un innovatore della letteratura.
Non pensava di scrivere una nuova pagina della letteratura.
Quando ero ragazzo, oggi ho quasi settant’anni ormai, di Gadda si rideva un po’. Si diceva lo scrittore ingegnere, quello strano tipo che si diverte a giocare con le parole. Allora il grande scrittore era Bacchelli, non era Gadda. Oggi c’è tutta una schiera di gaddiani che però non hanno le qualità di Gadda stesso, perché sono dei personaggi costruiti, ovviamente lo stesso discorso vale per Kafka anche lui non è innovatore del linguaggio e delle strutture però è innovatore degli ambienti. Ha una scrittura tutta allucinata. Io vorrei che quelli che fanno letteratura non si proponessero lo scopo di essere degli innovatori, ma seguissero veramente la loro natura. Se uno ha la natura di scrivere semplice, scrive semplice come l’acqua, come diceva Ginzburg di se stessa, se uno ha delle esigenze diverse faccia pure. Se io leggo Gadda sento la sua spontaneità, se leggo Sanguineti o Balestrini o qualche altro scrittore dell’avanguardia sento che scrivono in base ad un programma.
Parlando del futuro dell’umanità ha detto che questo futuro, se esiste, dipenderà dalle donne. Nel suo ultimo romanzo, La malga di Sir, c’è una figura femminile molto importante, Marianna. È una figura legata ad un personaggio reale o è totalmente frutto della sua fantasia?
Io sono uno scrittore d’immaginazione anche se non credo all’immaginazione assoluta. L’immaginazione è sempre ricavata dalla memoria e la memoria è frutto di un’esperienza letteraria e di un’esperienza quotidiana, all’interno delle situazioni di ogni giorno. Quindi anche Marianna risponde a queste esigenze. Mentre quello che dicevo a proposito delle donne è realmente ciò che penso. Ho la sensazione che l’uomo di oggi si sia allontanato troppo dalla natura, l’uomo si è dimenticato di far parte esso stesso della natura, che i boschi oppure i fiumi in qualche modo gli appartengono, li ha dentro ed esso stesso appartiene ai boschi, ai fiumi. Facciamo parte di una cultura che vive tutta all’interno della dimensione storica, e non geografica o biologica, che lascia queste cose agli scienziati mentre la gente comune e la gente di cultura in particolare si allontana sempre più da esse. Questa è la ragione per cui stiamo distruggendo la natura senza neppure accorgercene perché l’abbiamo allontanata sempre di più dalla nostra cultura. Dall’epoca di Gianbattista Vico ormai la natura non interessa più ai filosofi, oppure se ne parla, ne parla Hegel, Croce, Gentile, Marx, ma solo per dirne male. Per i marxisti ad esempio la natura va corretta perché la natura è ingiusta. Questo in astratto potrebbe anche essere un discorso giusto ma mi chiedo fino a dove l’uomo può spingersi? E infine, saprà autolimitarsi?

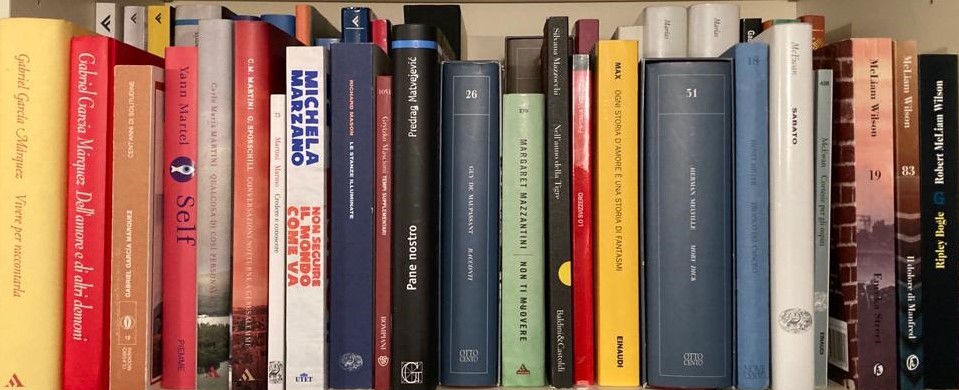
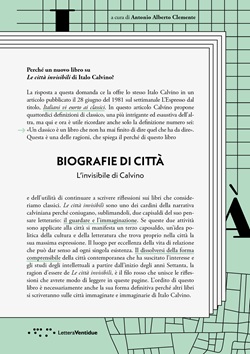
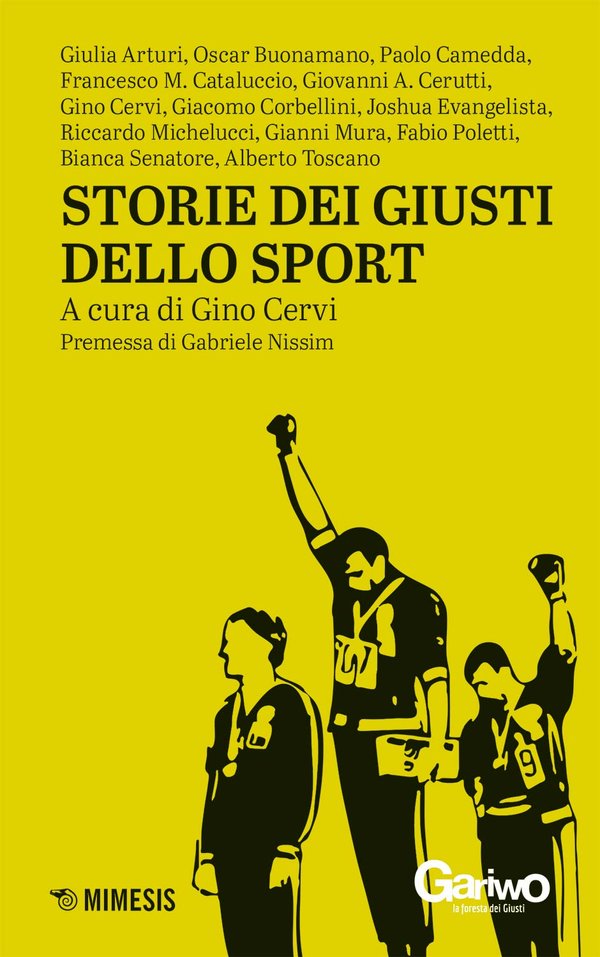
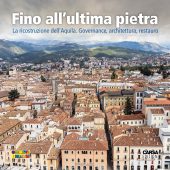
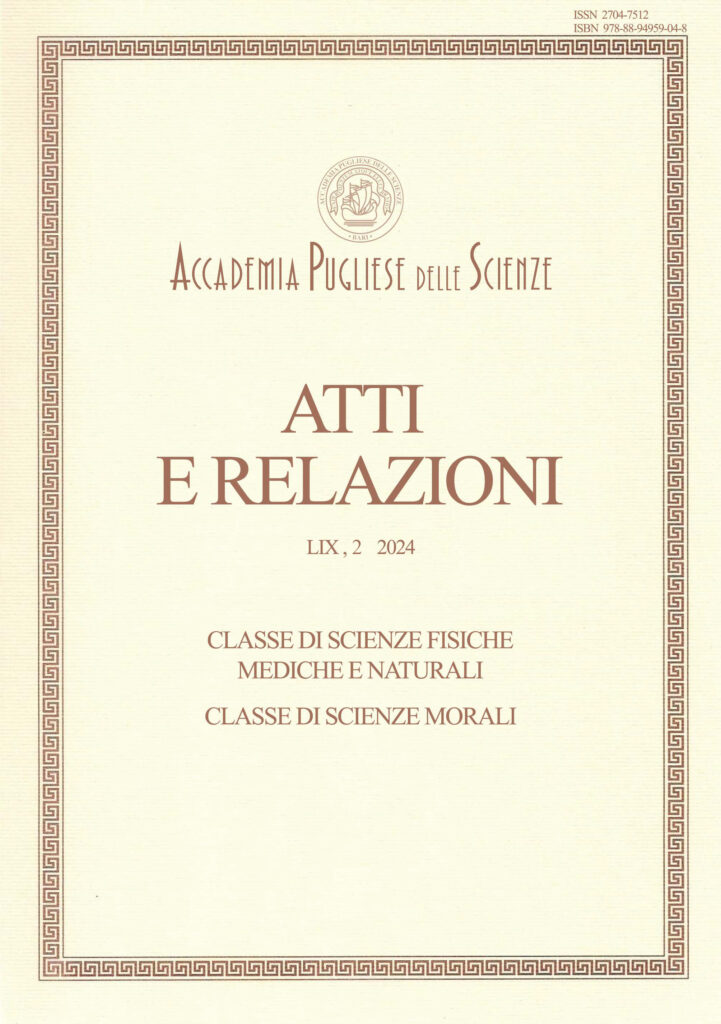

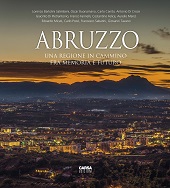
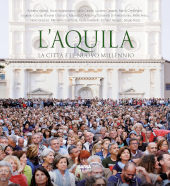
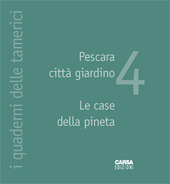



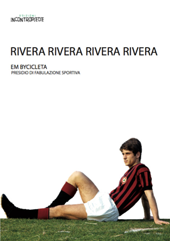
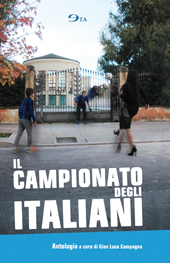
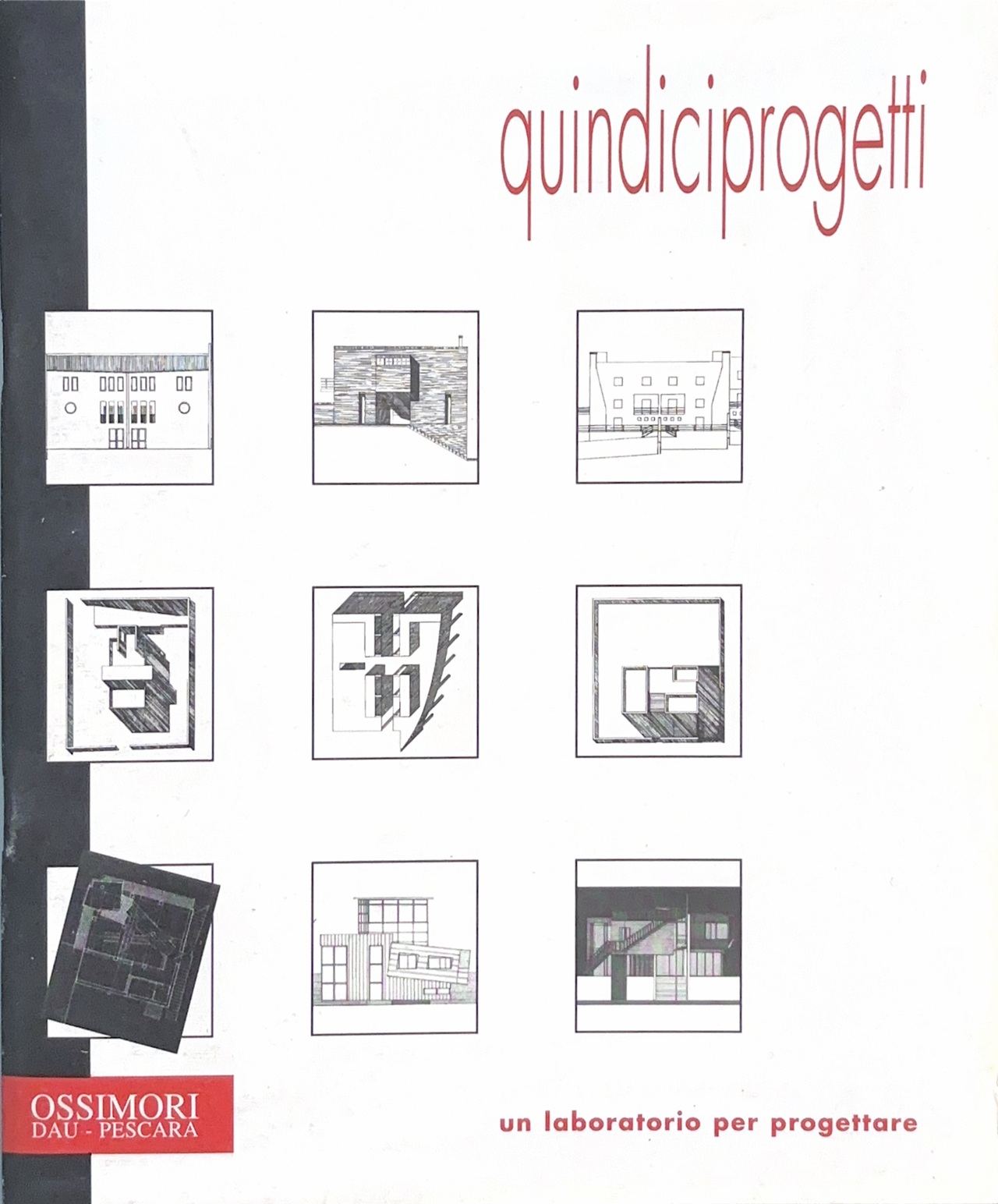





Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.