Ritorno al barocco è titolo di un progetto culturale che si sta realizzando a Napoli e nella sua provincia. Una serie di mostre, collegate e messe in rete unitamente ad altre manifestazioni culturali, che celebrano la magnificenza del barocco napoletano. La riproposizione di una stagione artistica fondamentale per Napoli e per l’Italia, uno degli ultimi periodi aurei del genio italiano. Fino a tutto il 1700 l’Italia è stata infatti, e senza ombra di dubbio, la nazione leader dell’intero pianeta. Dicevi Italia e intendevi mondo.
L’arte, l’architettura, il pensiero, venivano concepite in Italia, si concretizzavano e poi si diffondevano in ogni angolo della terra. Con l’avvento dei processi di industrializzazione il centro del mondo non è più stato Roma o Firenze. Londra, poi Parigi, poi il nuovo mondo, gli Stati Uniti d’America, e via via una serie di Paesi che mai prima avevano potuto competere con l’Italia diventano protagonisti e dominano la scena artistica globale. Comincia così per il nostro Paese un lento e inesorabile declino che sembra essere inarrestabile. Ritorno al barocco sembra essere, per queste ragioni, più una domanda che un’affermazione. Inoltre, per i tempi che stiamo attraversando, può essere un auspicio o è soltanto una considerazione? Perché siamo precipitati in una situazione impensabile fino a poche centinaia di anni fa, fino a prima dell’Unità d’Italia? Perché non siamo più capaci d’imporre, prima di tutto a noi stessi, uno stile di vita, comportamenti, di cui essere fieri e da esportare?
Un breve viaggio nel tempo della storia ci consente di mettere a fuoco alcuni aspetti che non spiegano tutto, ma aiutano a riflettere su ciò che stiamo costruendo attorno a noi. S’intersecano in questo breve viaggio due riflessioni. La prima potremmo definirla antropologica e attiene ai comportamenti della nostra comunità, al nostro modo di essere. Offre una chiave di lettura per provare a interpretare i comportamenti della nostra classe dirigente. La seconda è invece una riflessione sulle conseguenze che una classe dirigente mediocre e spesso cialtrona determina sulla società in cui viviamo.
Nel 1860, poco prima che nascesse ufficialmente l’Italia così come la conosciamo oggi, Giuseppe Garibaldi, che molto si stava prodigando per quella causa, tenne un breve ma significativo discorso. Era il pomeriggio del 7 settembre e dal balcone di Palazzo Reale che affaccia sull’attuale Piazza Plebiscito, ai napoletani che lo acclamavano dice: «Il primo bisogno dell’Italia era la concordia, il secondo l’unità della grande famiglia italiana; oggi la Provvidenza ha provveduto alla concordia colla sublime unanimità di tutte le province alla ricostruzione nazionale.» Parla di concordia, per superare la frammentazione, come priorità della nascente nazione. Alcuni anni più tardi, quando l’Italia era una giovane nazione e alla mancanza di concordia si era aggiunta nelle sue considerazioni la corruzione come carattere determinante della nascente classe dirigente, si affaccia prepotente sulla ribalta nazionale una pratica che ancora oggi è un tratto distintivo degli italiani: il trasformismo. È Agostino Depretis, più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, che in un discorso ai suoi elettori l’8 ottobre 1876 teorizza questa pratica tanto diffusa oggi nel costume italiano: «[…] spero che le mie parole potranno facilitare quella concordia, quella feconda trasformazione dei partiti, quella unificazione delle parti liberali della Camera, che varranno a costituire quella tanto invocata e salda maggioranza, la quale, ai nomi storici tante volte abusati e forse improvvidamente scelti dalla topografia parlamentare, sostituisca per proprio segnacolo una idea comprensiva, popolare, vecchia come il mondo, come il moto sempre nuova, il progresso…»
Eccessiva frammentazione e litigiosità, corruzione e trasformismo all’origine della classe dirigente del nostro Paese. Peculiarità che diventeranno ben presto patrimonio anche della gente comune. E mentre l’Italia perde centralità nei processi di trasformazione della nuova società industriale, la nuova classe dirigente che si afferma non sembra in grado di arrestare il suo evidente declino. Le conseguenze di questa nouvelle vague sono sempre più spesso soluzioni senza ritorno. Pensiamo per esempio alle nostre città e più in generale all’uso che si è fatto, negli ultimi centocinquant’anni, del territorio.
«Costruire significa collaborare con la terra, imprimere il segno dell’uomo su un paesaggio che ne resterà modificato per sempre; contribuire inoltre a quella lenta trasformazione che è la vita stessa della città.» Le parole che Marguerite Yourcenar fa dire al suo Adriano sembrano lontane anni luce dalla banalità del costruire e dallo scempio che si continua a perpetrare ancora oggi. Le città italiane nella loro nuova configurazione sono nel migliore dei casi dei pessimi dormitori. Sciatte, banali, brutte, senza alcuna valenza architettonica. E anche i nuclei urbani storici sembrano vivere solo ed esclusivamente prigionieri del loro passato. La città in ultima analisi, rispecchia la classe dirigente che la disegna e che ne decreta la nuova forma. A una classe dirigente mediocre e cialtrona corrisponde una città anch’essa mediocre e cialtrona.
«Se volgiamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», dice Tancredi al Principe di Salina nel Gattopardo.
È possibile che il vento del cambiamento e del progresso non riesca più a superare le Alpi?

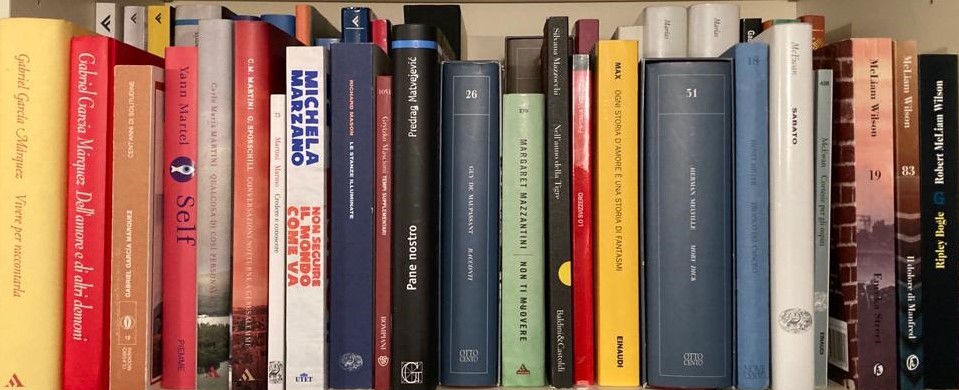
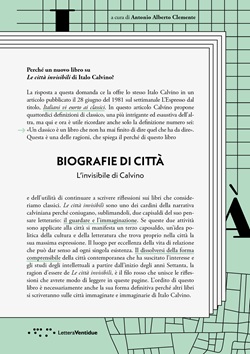
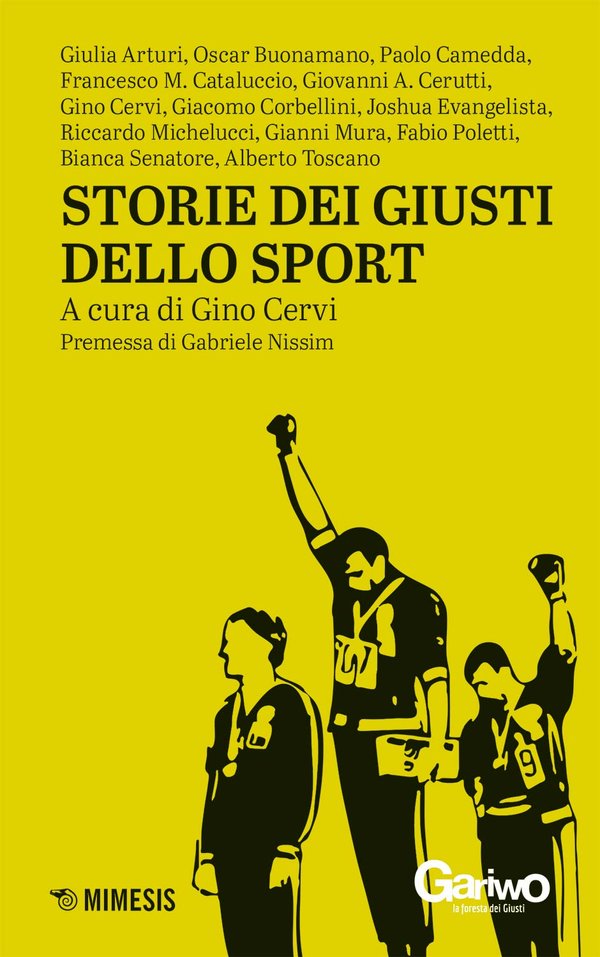
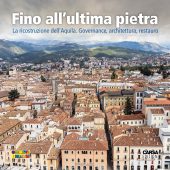
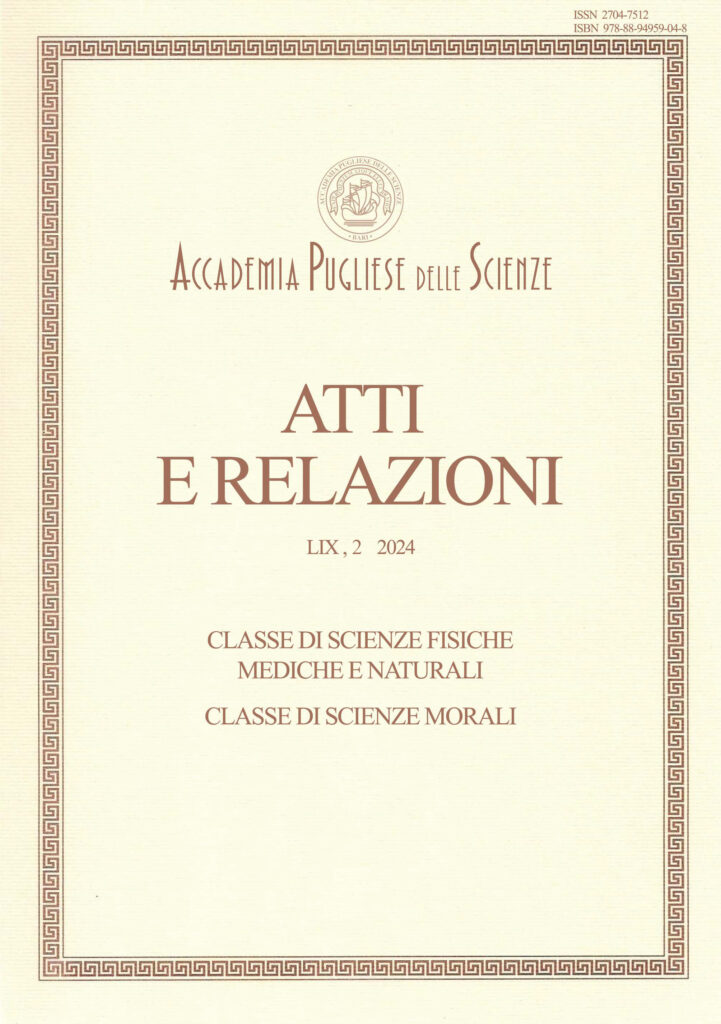

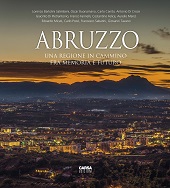
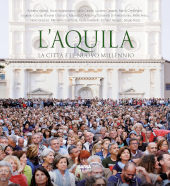
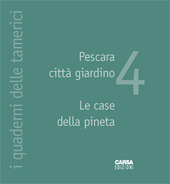



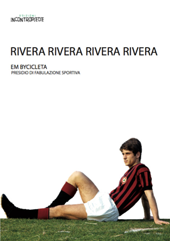
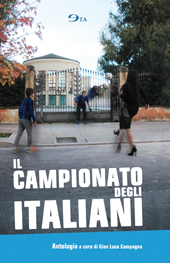
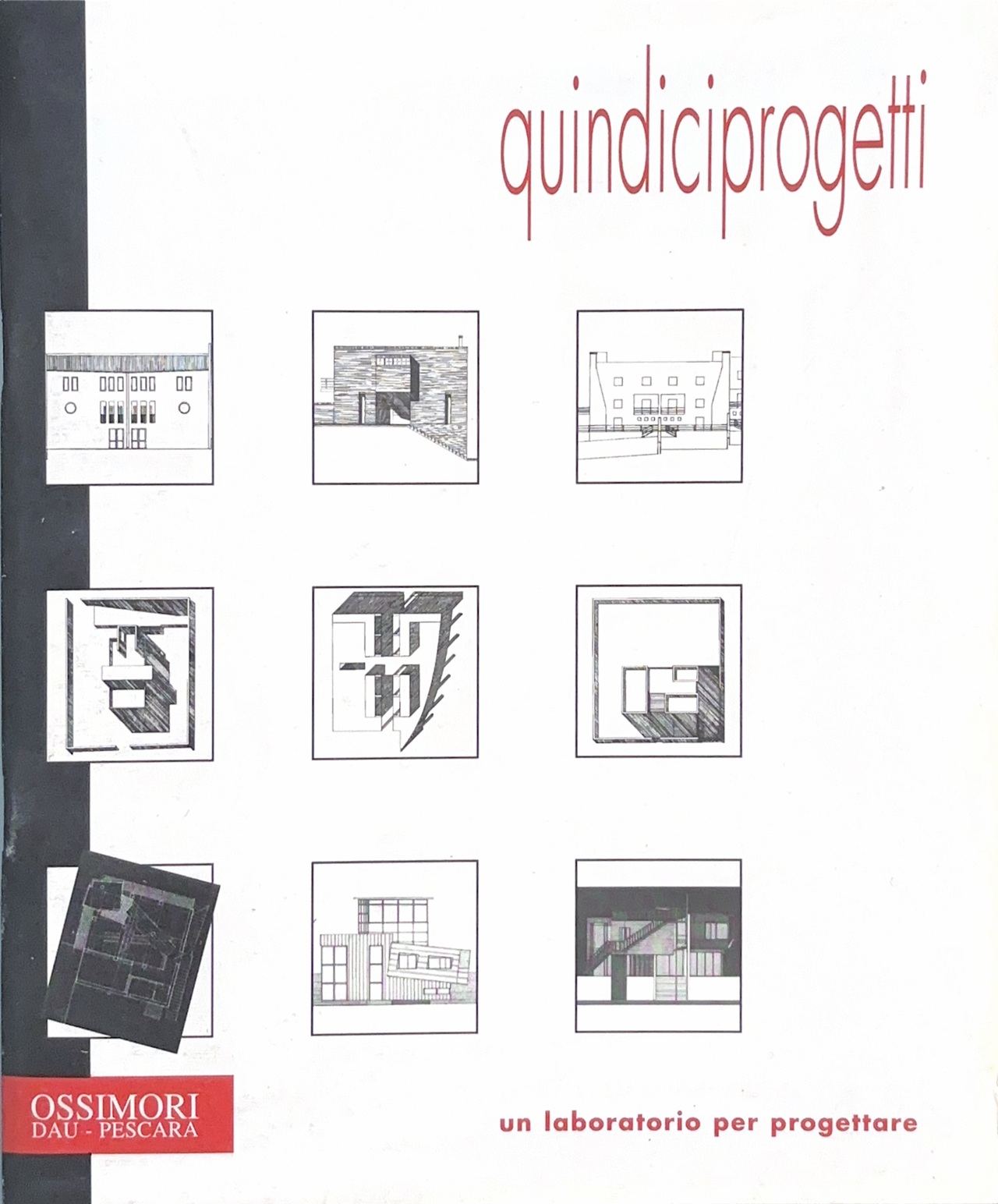






Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.