 Mentre salgo la scalinata che mi porta all’interno del Vittoriano, mi chiedo che cosa diavolo significhi fare una mostra su una giornalista e soprattutto cosa vedrò nelle sale che contengono la mostra. Perciò quando, percorsa la lunga scalinata, sono davanti al grande portone del palazzo che ospita la mostra sono ancora distratto dalla domanda che mi ronza in testa da più di un’ora: cosa significa fare una mostra su un giornalista?
Mentre salgo la scalinata che mi porta all’interno del Vittoriano, mi chiedo che cosa diavolo significhi fare una mostra su una giornalista e soprattutto cosa vedrò nelle sale che contengono la mostra. Perciò quando, percorsa la lunga scalinata, sono davanti al grande portone del palazzo che ospita la mostra sono ancora distratto dalla domanda che mi ronza in testa da più di un’ora: cosa significa fare una mostra su un giornalista?
L’ingresso è gratuito come gratuito è il guardaroba che è ormai quasi pieno quando arrivo. Lascio il cappotto e la borsa mentre tengo con me gli occhiali e la moleskine.
Nella prima sala ci sono una decina di persone. Mi sembrano tutte coppie. Coppie di signori anziani che osservano, leggono, con grande concentrazione tutto il materiale esposto. Uno di loro, un bel signore sulla settantina, capello brizzolato e molto elegante, rompe il silenzio che regna nella sala quando arriva davanti ad una parete dove ci sono tante foto di un’Oriana Fallaci giovanissima, tutte ordinate in maniera rigorosa in piccole cornici color legno scuro, e con voce chiara e forte dice: «Ma Oriana non era così triste. Era allegra, estroversa. Sempre e comunque una rompiscatole». Mi avvicino a questo signore, incuriosito dalla passione e la sicumera con la quale pronuncia quelle parole, e gli chiedo: «Scusi ma eravate amici?»
E lui per nulla sorpreso mi risponde con grande chiarezza: «No, ma è come se lo fossimo stati. Ho letto tutto quello che ha scritto, da quando ha iniziato a scrivere. Abbiamo la stessa età. E le posso assicurare che Oriana non corrisponde all’immagine che queste foto trasmettono».
Emilia era il nome di battaglia di Oriana Fallaci, allora quattordicenne, durante la Resistenza. Il papà, Edoardo Fallaci, antifascista ed esponente di Giustizia e Libertà, l’aveva coinvolta con il ruolo di staffetta di città e di montagna. E la foto che la ritrae sulla bicicletta con la quale effettuava il suo compito nella guerra antifascista, con le trecce che le delimitano e definiscono il viso, apre la mostra e ti accoglie nella prima sala.
Comincio a capire cosa possa significare una mostra su una giornalista e lo capisco sempre di più man mano che attraverso le sale.
Ci sono i suoi oggetti, le sue cose. Cappelli, occhiali, taccuini ed agende. Stralci dei suoi articoli. I video delle sue interviste con “La Storia”.
C’é l’elmetto, lo zaino e la borraccia che l’hanno accompagnata in Vietnam. Ci sono le lettere pubbliche e private. Ci sono le cartoline e le cartoline che inviava a suo nipote Edoardo. Mi ha colpito in particolare una di queste, inviata dall’America che dice più o meno così: «Caro Edoardino oggi due uomini hanno messo piede sulla Luna. Ciao Oriana.»
Oriana parla, Firenze e la vita, Le prime grandi inchieste, La corsa alla luna, Nei punti caldi del mondo, Il Vietnam, I libri, Cara Oriana, Un uomo, Libano e Golfo, Oriana intervista, La Rabbia e l’Orgoglio, sono le sale tematiche che s’incontrano in questo viaggio nella vita professionale e umana della Fallaci che è appunto la mostra: Oriana Fallaci. Intervista con la Storia.
Una vita, quella della Fallaci che ha attraversato il novecento, vissuta con intensità e passione. Intensità e passione e maestria e bravura che ha saputo mettere nel raccontare quel secolo per i giornali di tutto il mondo.
«Il mio giornalismo è passionale perché la mia mente è passionale, perché le mie idee e le mie credenze sono passionali. E la mia mente, le idee, non stanno né dentro gli umori uterini né dentro gli ormoni coglionari. Stanno nel cervello[…]».
L’uomo che sbarca sulla Luna, le guerre e la guerra in Vietnam in particolare, i grandi personaggi della storia del novecento, da Martin Luther King a Bob Kennedy, da Yasser Arafat a Deng Xiaoping, e poi ancora Indira Gandhi, Muammar Gheddafi, Henry Kissinger, Ruhullah Musavi Khomeini, Golda Meir, Reza Pahlavi, Ariel Sharon, e poi Alekos Panagulis, leader della resistenza greca contro il regime dei colonnelli al quale dedicherà uno dei suoi libri più belli: Un uomo.
«Era morto l’uomo che amavo e m’ero messa a scrivere un romanzo che desse senso alla tragedia. Per scriverlo m’ero esiliata in una stanza al primo piano della mia casa in Toscana ed era stato come infilarsi in un tunnel di cui non si intravede la fine, uno spiraglio di luce […] Dentro il tunnel lo spazio non aveva più spazio, il tempo non aveva più tempo e la Storia non esisteva. Non vedevo mai nessuno, non rispondevo mai al telefono, non leggevo mai i giornali: il mio cervello era un muscolo che agiva esclusivamente in funzione della fatica in cui mi stavo distruggendo, del fantasma a cui cercavo di ridare vita col ricordo e con la fantasia.»
Con queste parole la Fallaci rievoca il ricordo dei tre anni impiegati per scrivere Un uomo agli studenti del Columbia College di Chicago nel 1980.
Ecco cosa significa fare una mostra su una giornalista, mi dico. Spiegare attraverso immagini e parole il suo percorso e soprattutto riuscire a far capire perché la Fallaci diceva: «Già quando avevo cinque-sei anni non concepivo nemmeno un mestiere che non fosse il mestiere di scrittore. Il giornalismo all’inizio per me fu un compromesso, un mezzo per arrivare alla letteratura.»
E qui capisco un’altra cosa, perché sulla sua tomba c’è scritto: Oriana Fallaci, scrittore.
Il romanzo Insciallah, che gli vale peraltro il Super Premio Bancarella nel 1990, da inizio, prima di un lungo, lunghissimo, silenzio che si autoimpone, alla riflessione sull’Islam e sul fondamentalismo islamico.
Poi arriva l’11 settembre 2001, e con l’11 settembre arriva La rabbia e l’Orgoglio. E qui inizia un’altra storia. Un lungo articolo scritto per Il Corriere della Sera rompe l’altrettanto lungo silenzio che si era imposto.
Una requisitoria, un’invettiva piena di rabbia, nella quale la Fallaci si scaglia contro l’Occidente, debole, a suo avviso, nei confronti del mondo islamico.
Yasser Arafat, per quello che rappresenta, è uno degli uomini contro il nutre un vero e proprio odio che si evince dalle parole che gli dedica nella parte iniziale e centrale dell’articolo: «Perché se lo incontrassi di nuovo, o meglio se gli concedessi udienza, glielo urlerei sul muso chi sono i martiri e gli eroi […] I suoi nonni, Illustre Signor Arafat, non ci hanno lasciato che qualche bella moschea e un libro col quale da millequattrocento anni mi rompono le scatole più di quanto i cristiani me le rompano con la Bibbia e gli ebrei con la Torah […] Ma cambiamo discorso. Io sono molto ammalata, si sa, e a parlare con gli Arafat mi viene la febbre.»
Un’exursus che attraversa la cultura occidentale e quella islamica e le mette a confronto. Un confronto che si alimenta di aneddoti personali, di storia e che ammalia il lettore in un crescendo di emozioni che la sua scrittura oggettivamente crea.
Questo articolo ha dato il via in Italia ad un dibattito che spesso ha superato gli stessi intenti della sua autrice, credo. È stato vivisezionato in ogni sua parte e ogni sua parte è stata oggetto di commenti ed ha scatenato tante passioni e mai indifferenze, disinteresse.
Dopo questo articolo, che la Fallaci termina con un avvertimento per l’allora direttore del Corriere, Ferruccio de Bortoli: «Col che ti saluto affettuosamente, caro il mio Ferruccio, e t’avverto: non chiedermi più nulla. Meno che mai, di partecipare a risse o a polemiche vane. Quello che avevo da dire l’ho detto. La rabbia e l’orgoglio me l’hanno ordinato. La coscienza pulita e l’età me l’hanno consentito. Ma ora devo rimettermi a lavorare, non voglio essere disturbata. Punto e basta», ci saranno ancora tre libri. Il primo è proprio la pubblicazione dell’articolo stesso, La rabbia e l’orgoglio, e poi a distanza di tre anni altri due volumi sullo stesso tema, La forza della ragione e L’Apocalisse. Inutile sottolineare che questi libri hanno venduto milioni copie.
Sono arrivato alla fine del percorso e della mostra e devo ammettere che sono stanco. E la stanchezza non è una stanchezza fisica ma mentale. Sono anche un po’ frastornato.
La vita di questa donna è stata una vita piena di tante cose e di tante vite e che ha attraversato tante vite. Una vita così piena presuppone la presenza di tante Oriana Fallaci.
C’è una Oriana Fallaci attivista convinta della Resistenza, una Fallaci grande giornalista, forse la più grande giornalista italiana che si è saputa imporre in tutto il mondo, c’è la Fallaci scrittore e poi c’è la Oriana Fallaci del dopo 11 settembre.
Molti, soprattutto a sinistra, tendono ad evidenziare l’ultimo aspetto della sua vita e per questo ad esprimere un giudizio totalmente negativo su di lei. Molti, soprattutto a destra, tendono ad evidenziare l’ultimo aspetto della sua vita e per questo ad esprimere un giudizio totalmente positivo su di lei.
Niente di nuovo sotto il sole. Dispute ideologiche o post ideologiche che non aiutano a capire e che soprattutto tendono a considerare solo un aspetto, peraltro parziale, della sua immensa produzione culturale.
Io sono totalmente e convintamente contrario alle tesi che la Fallaci sostiene nell’articolo La rabbia e l’orgoglio. Quell’articolo non mi piace. Non mi piace il sentimento che esprime, la rabbia appunto, e nemmeno l’orgoglio a cui si aggrappa o si appella. E trovo alcuni passaggi ingiustamente ingenerosi nei confronti del nostro Paese, come per esempio quando scrive:«[…]Così, quando ho visto bianchi e neri piangere abbracciati, dico abbracciati, quando ho visto democratici e repubblicani cantare abbracciati «God save America, Dio salvi l’ America», quando gli ho visto cancellare tutte le divergenze, sono rimasta di stucco… Ah, se l’Italia imparasse questa lezione! È un Paese così diviso, l’Italia. Così fazioso, così avvelenato dalle sue meschinerie tribali.»
Ingiustamente ingenerosi perché in momenti così drammatici, com’è stato sicuramente l’11 settembre per l’America, anche l’Italia ha dimostrato di saper essere unita, forte e solidale. Mi vengono in mente l’alluvione di Firenze o i terremoti in Friuli e in Irpinia. In queste occasioni tutto il Paese ha saputo reagire unito. A Firenze come a Gemona, a Pescopagano come a Cividale del Friuli, c’era tutta l’Italia che spalava tra le macerie o recuperava libri sommersi dal fango. Ed erano uomini e donne del nord e del sud del Paese che insieme hanno ricostruito o recuperato morti e feriti tra le macerie. Esattamente come hanno fatto i bianchi e i neri di New York o i tanto, e giustamente, celebrati vigili del fuoco americani.
E poi quel sentimento di superiorità dell’Occidente così vergognosamente ostentato in faccia all’altra metà del mondo. Quel continuo alimentare odio e disprezzo per interi popoli che non riesco a capire e che non voglio nemmeno giustificare.
Mi sembra, in ultima analisi, che da quell’articolo trasudi un odio e un’intolleranza che non sono accettabili proprio in nome di quella libertà e di quel volersi liberare da tutti i fascismi, di destra e di sinistra, che la stessa Fallaci ha inseguito per tutta, o quasi, la sua vita.
In ogni caso tutto ciò non può farmi dimenticare quello che c’è stato prima dell’11 settembre. Non mi fa dimenticare le battaglie e il voto per i Radicali, non mi fa dimenticare le battaglie contro la guerra, non mi fa dimenticare il suo essere in prima linea nell’affermare il movente politico dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, non mi fa dimenticare le meravigliose pagine di Un uomo e di Se il sole muore.
Perciò pur esprimendo la mia contrarietà totale alla Fallaci de La rabbia e l’orgoglio non riesco a non essere d’accordo con quanto afferma Lucia Annunziata in una testimonianza riportata sul catalogo della mostra: «[…] Oriana Fallaci ha avuto una vita professionale eccezionale, ha venduto milioni di libri, è stata un modello per intere generazioni di donne, e ha inventato molte cose del moderno giornalismo: dopo di lei la tecnica (meglio: l’arte) dell’intervista non sarà mai più la stessa […] È stata la prima giornalista di un mondo globalizzato – di lingua italiana, profondamente fiorentina e italiana, ma a casa solo in aereo e a New York […] Sappiamo però che la sua ultima voce, l’ultimo capitolo del suo libro professionale l’ha scritto a New York, dall’America, sull’America, ma dedicato all’Italia. Il lavoro che ha fatto dopo l’11 settembre è discusso e discutibile – forse. Ma d’immensa vitalità. Prendere o lasciare, amarla o meno, se non è Oriana Fallaci una Grande Italiana, allora non ne conosciamo molte.»
Volevo vedere questa mostra e sono contento di averla vista.
Volevo vedere questa mostra soprattutto per riflettere su tutto ciò che si è scritto e si è detto su questa donna, dopo la sua morte. Sulle sue idee e sul suo lavoro.
Adesso che l’ho fatto mi sento meglio, molto meglio, per certi versi sollevato.

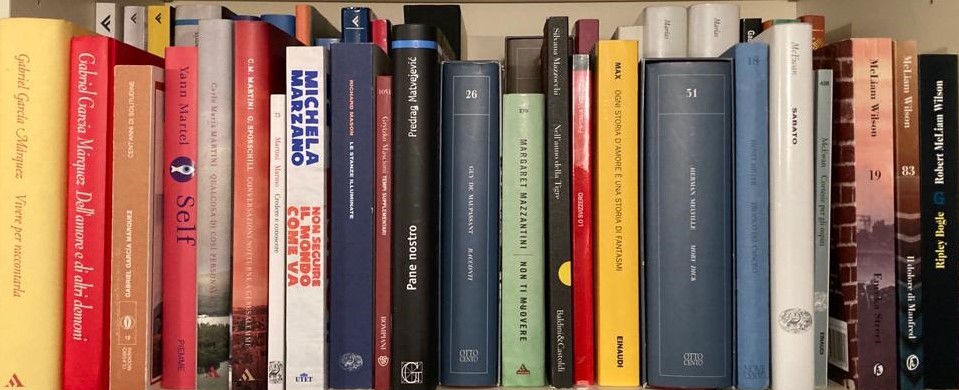
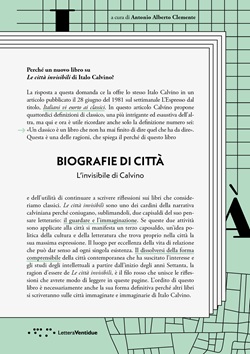
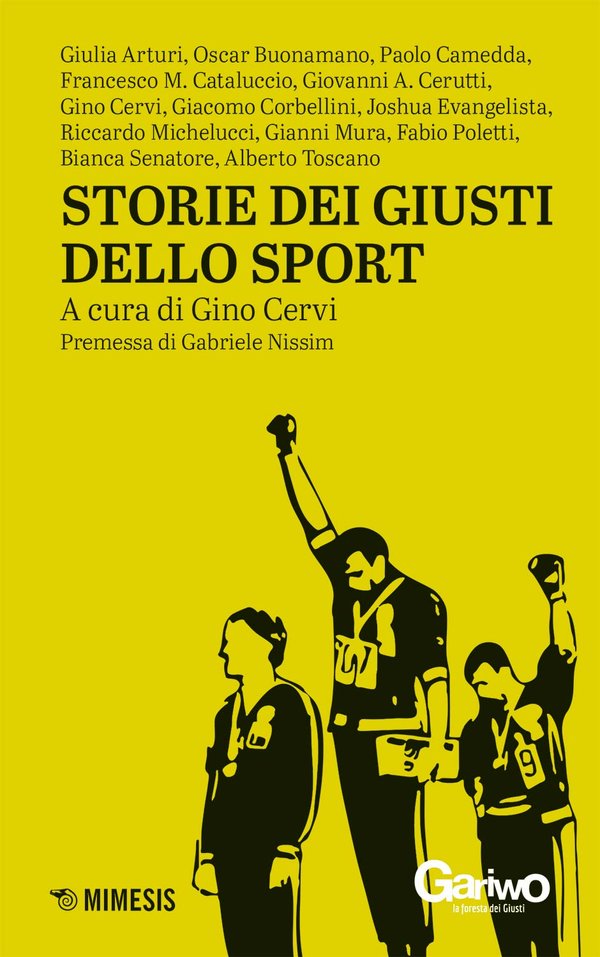
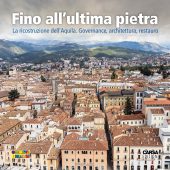
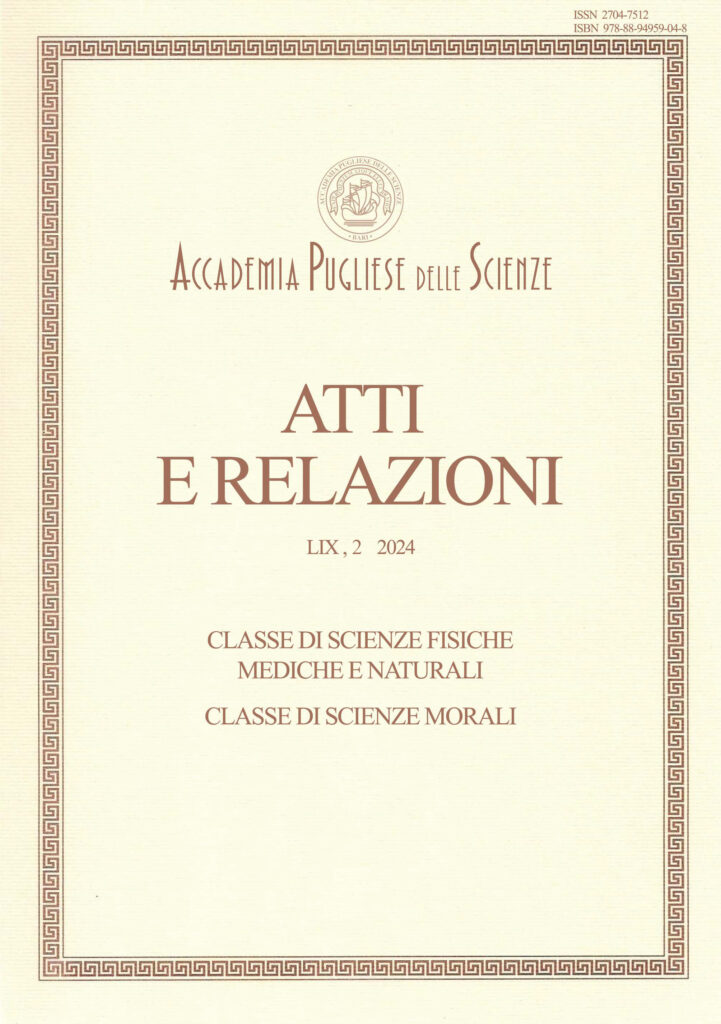

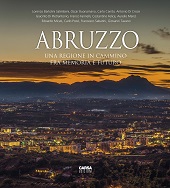
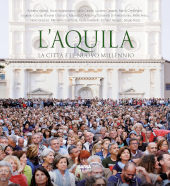
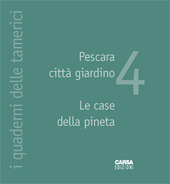



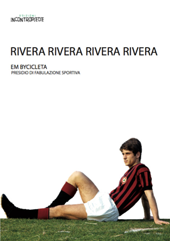
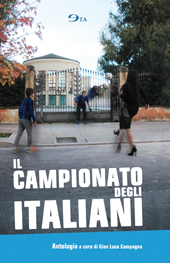
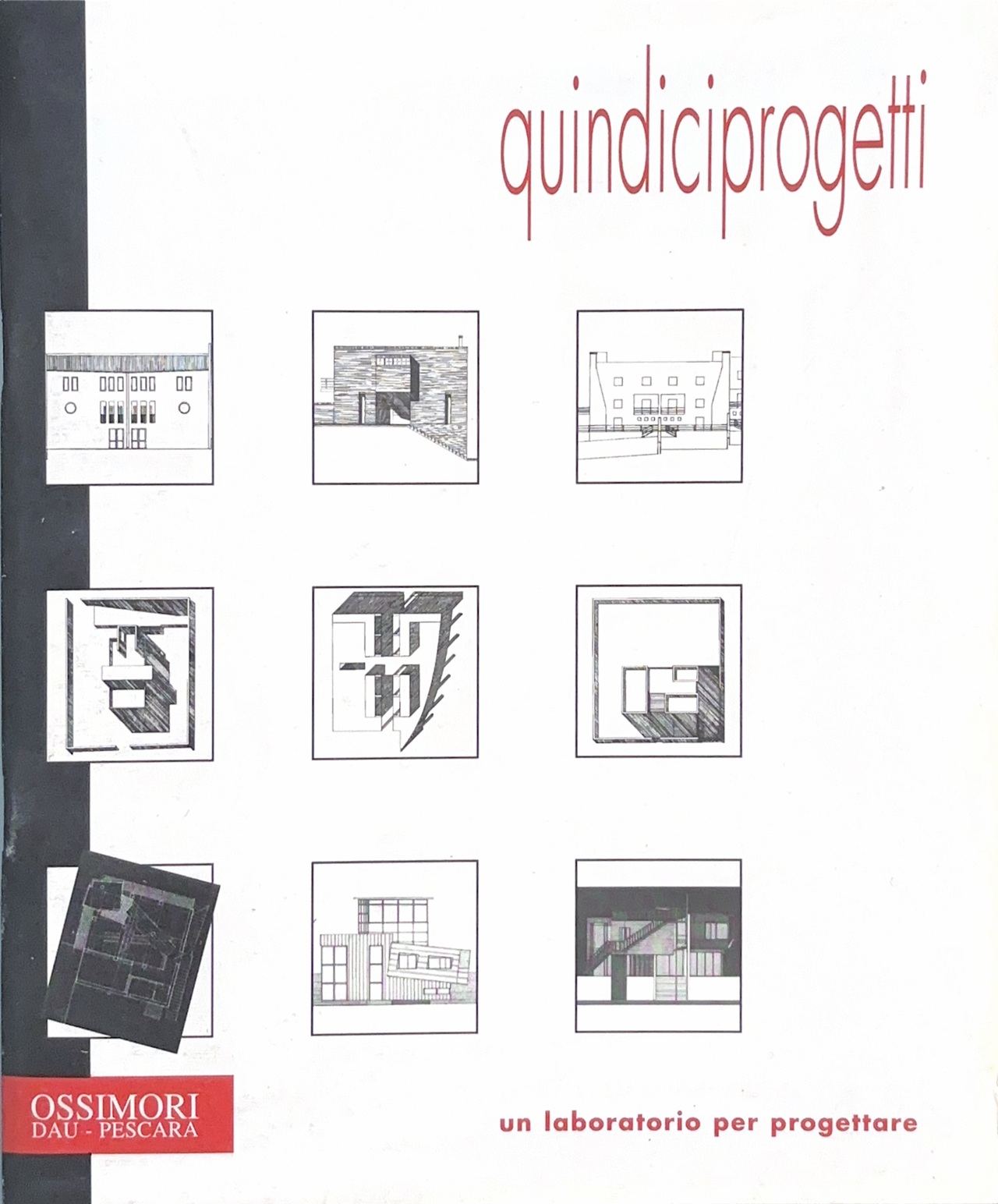





Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.