Questo articolo è pubblicato sul quotidiano Roma, il giornale di Napoli
* Qui è pubblicato in una versione più lunga che include alcune citazioni
Nel 1963, l’anno in cui principia il romanzo di Giovanna Casadio, Arrivammo a destinazione, sono stati 183.000 gli italiani del Mezzogiorno emigrati al Nord. E dunque, anche se l’autrice scrive che questo romanzo «è una storia di femmine», «una storia di mari e di marinai» e «soprattutto la storia di Nevio Boni», pur rispettando ciò che ella scrive, penso sia soprattutto una storia di emigrazione e, per estensione, una storia tra le tante storie, della grande migrazione degli italiani del Sud verso l’Italia del Nord e il resto del mondo. Una storia che merita di essere raccontata e che continuerà a vivere nel tempo, rinnovandosi di generazione in generazione.
Una storia fatta di storie, come quella di Sebastiano, raccontata o cuntata come scrive Giovanna Casadio, «c’è un attimo, subito dopo la morte, in cui ogni desiderio è esaudito. È l’istante in cui chi muore può chiedere scusa a chi ha offeso, tenersi accanto l’amore più grande, sedersi sul molo ad abbracciare il mare».
Ed è proprio con la morte di Sebastiano, papà di Clorinda e marito di Miriam, che ha inizio questa storia e «principiò il disastro».
Una storia di migrazione in cui il legame con la terra d’origine, la Sicilia, è innanzitutto nella lingua: il dialetto. Un dialetto mai ostentato né reso modaiolo, ma autentico, vero ancoraggio alle radici. Diventa protagonista ogni volta che la narrazione torna alla terra natia, perché solo quel suono, quella cadenza, può restituire pienamente il senso delle cose. Soprattutto modi di dire che sintetizzano meglio di tante sintesi e, poi, ancora, aggettivi che più di tutti riescono a identificare luoghi ed esprimere giudizi.
È vero, comunque, che è una storia di femmine, di Clorinda soprattutto, la nonna: «Di Clorinda, mia nonna, a me piace il profumo, anche questo qui del Nord che è di candeggina, mi piacciono i capelli che sono ancora un po’ rossi e molto bianchi, gli occhi neri che dicono siano anche i miei, però lei ha gli occhiali. Ma più di tutto mi piace come ogni cosa torna al suo posto, quando lei c’è […] L’altra cosa di Clorinda che mi piace moltissimo è come racconta».
Questi profumi e cunti ben si sposano e amalgamano con il profumo e il racconto di Sicilia che Giovanna Casadio propone. Una Sicilia autentica, senza orpelli, abitata fin dalla preistoria da molti e diversi popoli, ognuno dei quali ha lasciato qualcosa di sé sulla pelle e nelle informazioni genetiche dei siciliani. Una Sicilia parte di un’Italia molto diversa da oggi. Mietevano vittime la spagnola e il vaiolo e non tutti erano iscritti all’anagrafe alla loro nascita. Un’Italia in costruzione che si realizzerà così come la vediamo oggi solo a partire dal secondo dopoguerra, lasciando indietro proprio la Sicilia e tutto il Mezzogiorno ancora oggi corpi separati dal resto del Paese, ma che riescono a far innamorare tutti coloro che l’attraversano, anche solo per qualche giorno.
Potenza della cultura diffusa nel Regno delle Due Sicilie che nel corso dei secoli ha seminato e sedimentato a lungo e in profondità, parole, modi di fare, atteggiamenti che fanno parte del codice scritto di ognuno degli abitanti del Mezzogiorno d’Italia. Per esempio, quando leggi «Clorinda, ’a figghia del capitano, non si faceva ’ngiarmare da niente e da nessuno», anche se sei calabrese, campano, pugliese, lucano, capisci cosa vuol dire ’ngiarmare.
Figuriamoci se non si sarebbe dovuto innamorare il maresciallo dei carabinieri Nevio Boni che incontriamo qualche pagina più avanti della bella descrizione di Clorinda, che in questa confidenza rivela tutto il suo amore e il pieno riconoscimento per la sua terra d’adozione.
«Vedi, Miriam, vedi il rosa di questo tramonto? È casa mia. E il profumo delle magnolie, dei mandarini, dell’erba citronella, dei gelsomini, persino la puzza dello sterco dei cavalli, le alghe marce, il pesce andato a male sono l’aria che mi apice respirare. Lo scirocco appiccicoso e malevolo è mio amico. La tramontana non mi spaventa […] Da questo nessuno può esiliarmi, quest’isola è casa mia».
Boni, il maresciallo Nevio Boni, incarna lo Stato. Lo Stato con la sua faccia migliore se la faccia è proprio quella di Nevio Boni. Un maresciallo poeta o poeta maresciallo che facendosi carico dei problemi delle persone s’immedesima in modo così totale e pieno da diventare uno di loro e di pensare come loro. Un siciliano tra siciliani, lui che è romagnolo di nascita, cresciuto a Genova, adottato dalla Sicilia. Nevio Boni è d’animo gentile, è considerato un eroe e s’innamora di Miriam, la capitana, moglie e vedova del capitano Sebastiano Moncada.
Una storia con imponenti figure maschili, ma costruita su quattro figure femminili, Miriam, Clorinda, Maria Lucente e Rosannù. Una storia che si dipana dal 1915 al 1963 e che Giovanna Casadio ci racconta e ci fa vivere come due tempi al presente che, pur giustapponendosi, concorrono a dipanare i dubbi su ciò che successe quando tutto ebbe inizio, nel maggio del 1915.
Giovanna Casadio ci porta a destinazione e scioglie questi dubbi di cui, ovviamente, non vi darò conto. Vi do conto invece della bellezza di questo romanzo e della capacità dell’autrice di averci saputo trasportare in un mondo pieno di colori, sapori, umanità. Un mondo in perenne tensione.
E se dovessi riassumere e fissare questo romanzo in un’immagine, ecco cosa farei. Chiuderei gli occhi respirando a pieni polmoni l’effluvio che trasporta quel vento di scirocco, «in quella città da tutti i lati bagnata dal mare, nella punta estrema dell’occidente siciliano, città di commerci e di molte prepotenze…», e abbraccerei il mare.

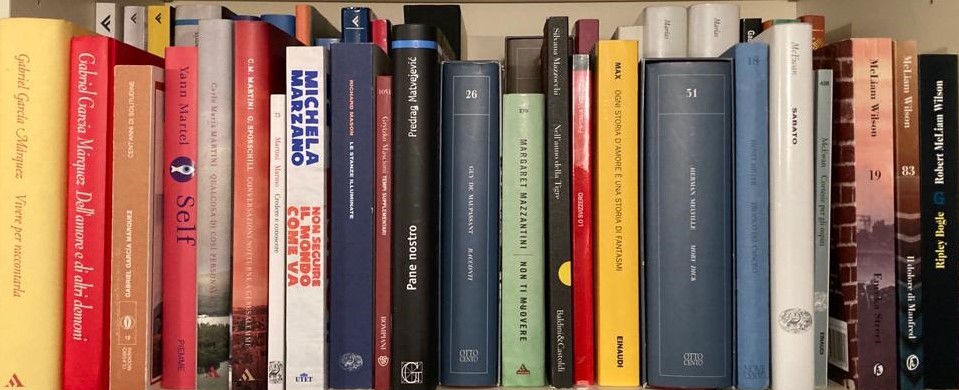
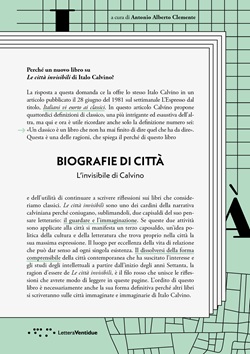
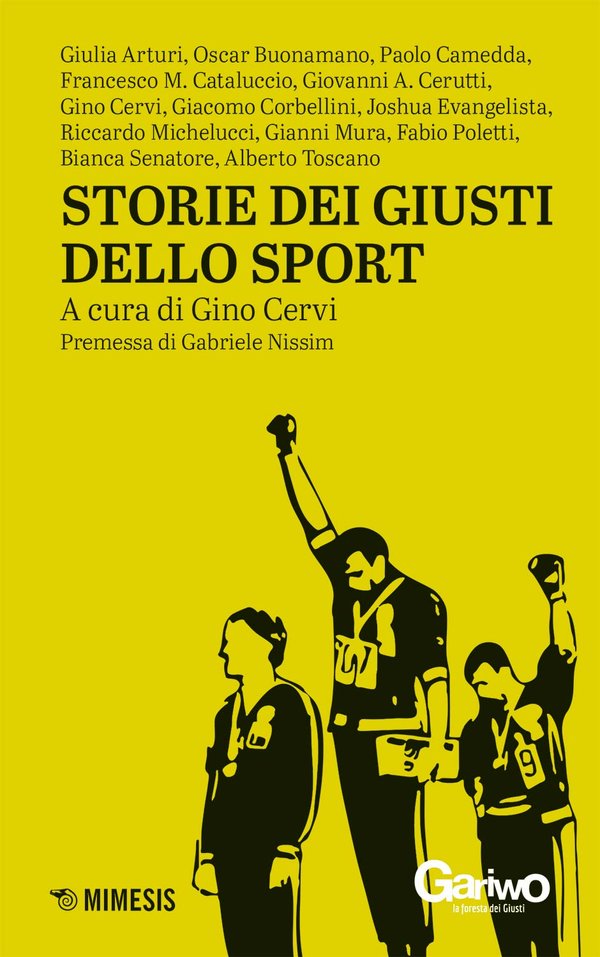
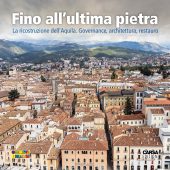
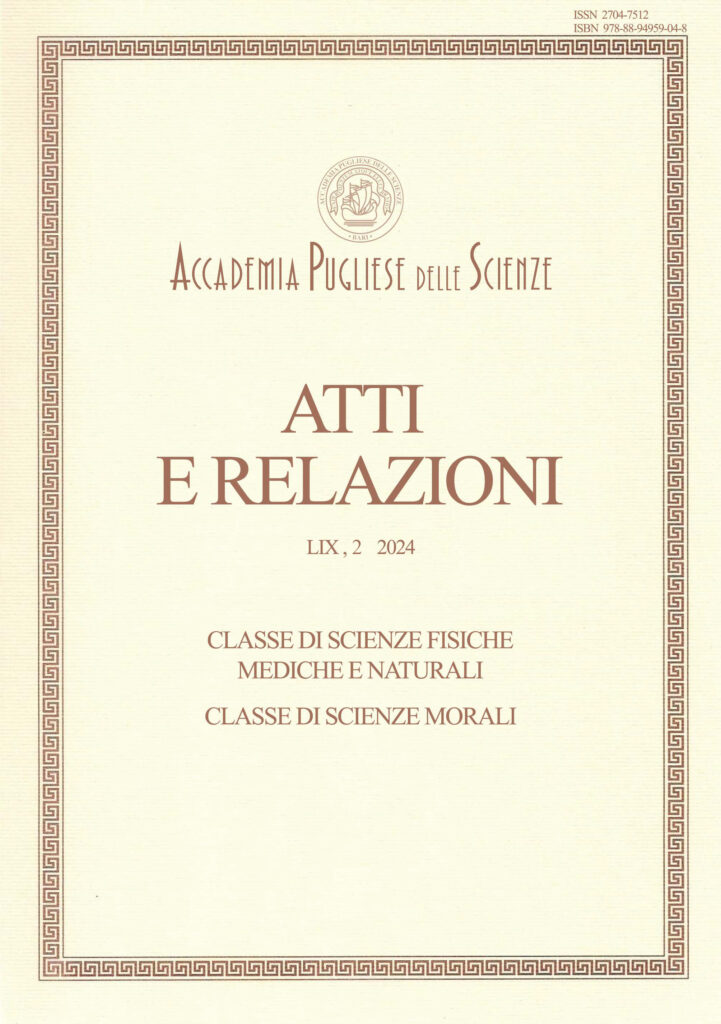

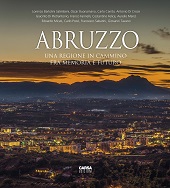
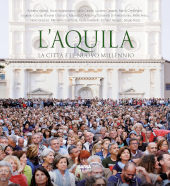
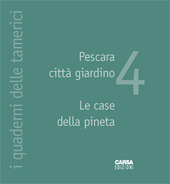



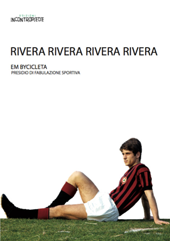
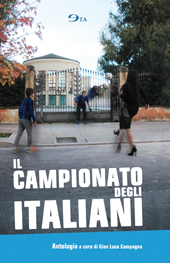
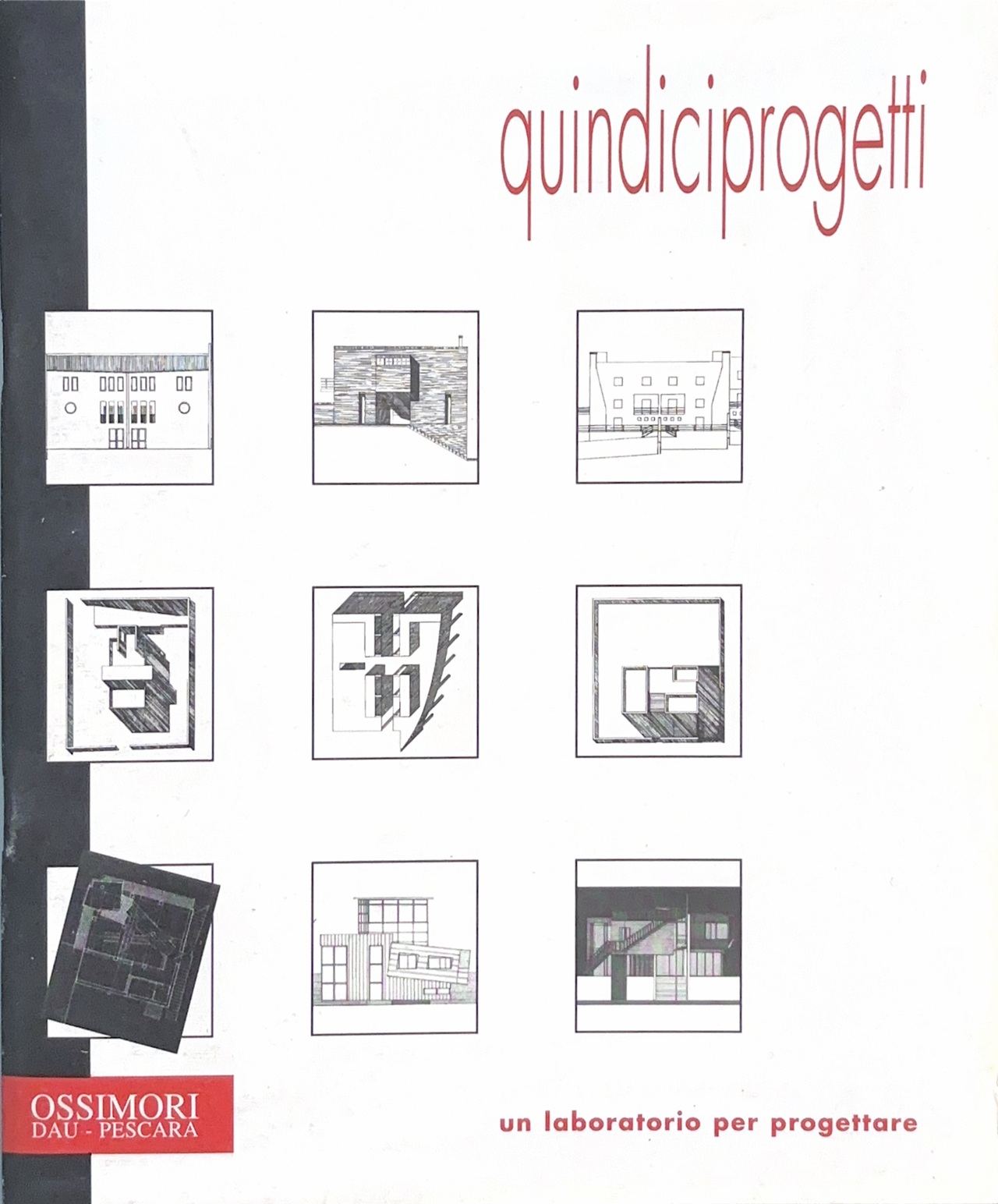







Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.